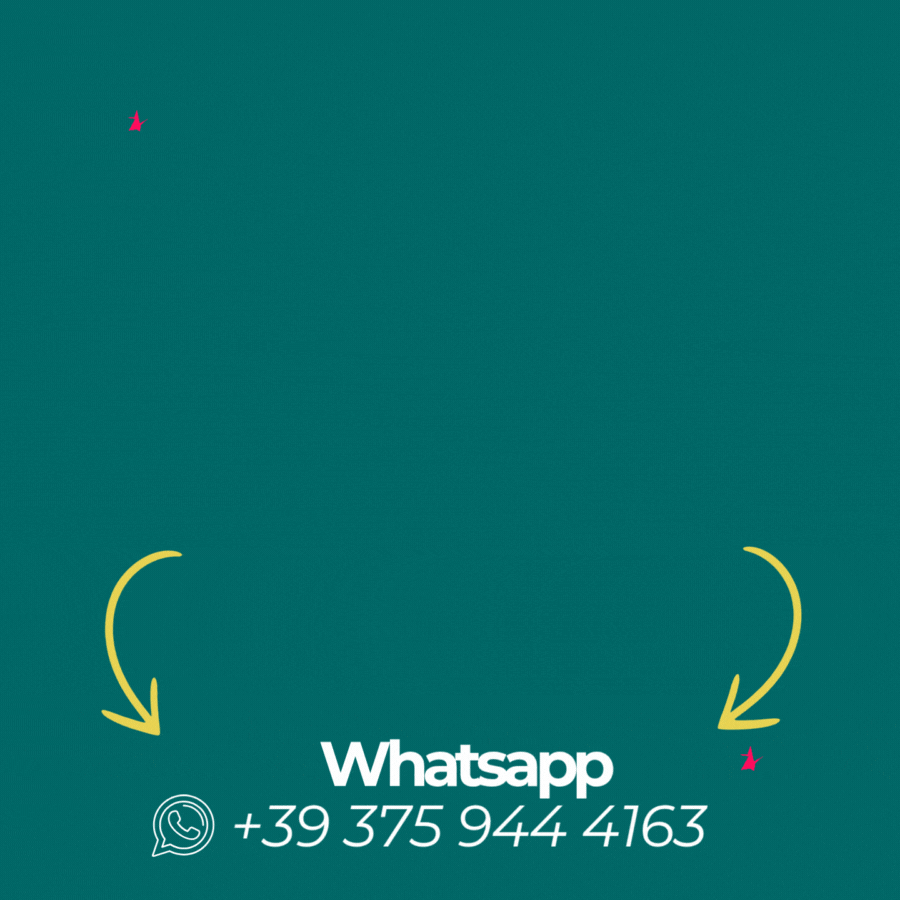Di fronte all’orrore del “Sarajevo Safari”, l’indagine della Procura di Milano non è solo un atto giudiziario, ma uno specchio deformante calato sul nostro passato prossimo. Tra listini prezzi per uccidere bambini e “turisti della morte” partiti dall’Italia, la testimonianza di Edin Subašić squarcia il velo su una delle pagine più macabre del dopoguerra europeo.
C’era un tempo in cui, per una certa élite annoiata e feroce, il confine tra lo sport e l’omicidio non era che una questione di tariffa. Non si parlava di caccia al cervo o al cinghiale nelle valli bergamasche, ma di caccia all’uomo tra le macerie di una Sarajevo agonizzante. Lo chiamavano “Sarajevo Safari”: un pacchetto turistico dell’orrore che prevedeva il trasporto VIP verso le colline controllate dalle milizie serbe, un fucile di precisione tra le mani e un civile bosniaco nel mirino.
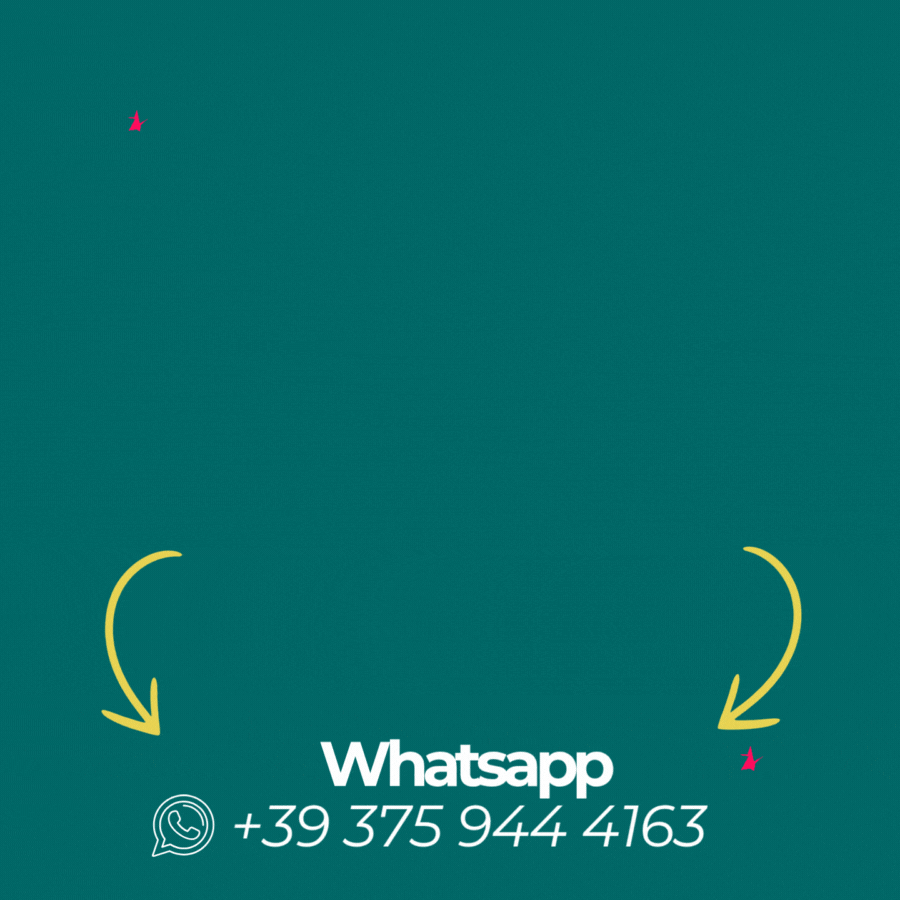
Oggi, a trent’anni da quegli spari, la Procura di Milano ha deciso di guardare nell’abisso. L’indagine sui “turisti di guerra” italiani non è solo un atto dovuto alla storia, ma un proiettile che torna al mittente. Dalle testimonianze raccolte, tra cui spicca quella lucida e terribile di Edin Subašić, ex agente dell’intelligence bosniaca, emerge un sistema logistico impeccabile. Non erano lupi solitari, ma clienti assistiti dai servizi segreti di Belgrado. Il “safari” aveva le sue regole e, soprattutto, i suoi prezzi.
“Le cifre oscillavano dai cinquantamila marchi ai trecentomila euro delle vecchie valute”, spiega Subašić. “Il listino seguiva la tipologia del bersaglio: uccidere un bambino costava più che abbattere un soldato”.
È qui che la disumanizzazione tocca il suo apice: la vita umana ridotta a trofeo, con il sovrapprezzo per l’innocenza. Perché l’inchiesta proprio nella “nostra” gran Milàn? Perché è da lì che, secondo i rapporti d’intelligence dell’epoca, partivano i “cacciatori”. Già nel 1994, il SISMI (l’allora servizio segreto militare italiano) era stato informato della presenza di cittadini italiani sulle colline di Pale. La risposta di allora fu un rassicurante quanto ambiguo “gruppo neutralizzato”. Ma per trent’anni, su questi nomi, è calata una cortina di nebbia che solo oggi la tenacia del giornalista Ezio Gavazzeni e l’apertura del fascicolo del pm Alessandro Gobbis stanno provando a diradare. Anche la nota trasmissione Rai “Chi l’ha visto?” si è occupata del caso sentendo una giornalista che ha fornito una importante testimonianza per rintracciare un 80enne italiano attualmente indagato, ma che nega ogni responsabilità.
Il quadro che emerge è quello di un’organizzazione transnazionale che sfruttava persino i voli umanitari per trasportare i killer. Trieste, Belgrado, Pale: tappe di un viaggio verso la barbarie autorizzato dal silenzio assenso delle autorità locali serbe, che oggi gridano al “complotto per infangare il popolo”, mentre ignorano le prove di una commercializzazione sistematica del massacro.
Qualcuno dirà che è passato troppo tempo. Che quei cacciatori sono ormai vecchi, che la Bosnia è un ricordo sbiadito. Ma i crimini di guerra non conoscono prescrizione, né morale né giuridica. Se l’indagine di Milano riuscirà a dare un nome a chi pagava per sparare sui bambini che andavano a prendere l’acqua, avremo fatto un passo avanti non solo verso la giustizia, ma verso la comprensione di quanto sia sottile il confine tra civiltà e ferocia.
Il “Sarajevo Safari” non è stata solo una tragedia bosniaca; è stata una macchia indelebile sulla coscienza europea e, specificamente, italiana. Affrontare questo mostro significa dire che la vita non ha un prezzo, nemmeno quando la guerra sembra autorizzare ogni follia.