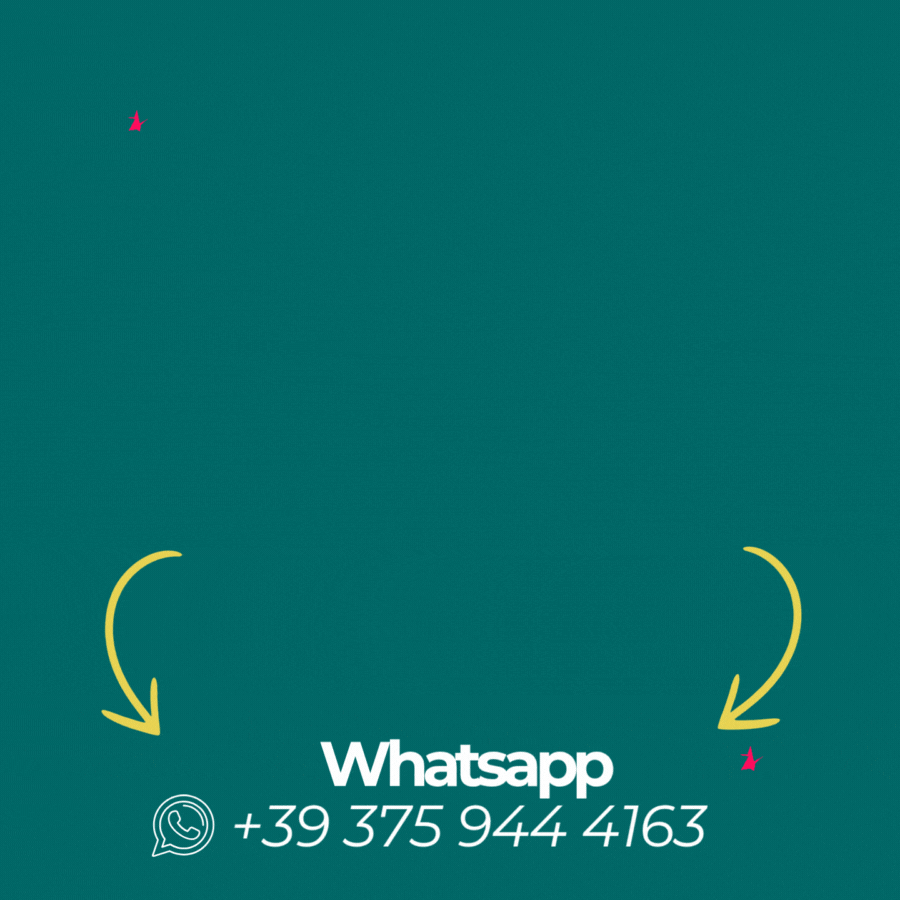La diatriba sul Ponte sullo Stretto di Messina è tornata prepotentemente a polarizzare l’agenda pubblica, e nel fragore delle odierne polemiche si è smarrita una verità storica che suona come un paradosso: la sinistra italiana, oggi irremovibile sul fronte NoPonte, fu in passato una sua convinta e ideologica sostenitrice. L’episodio chiave risale all’8 giugno 1967, quando il Segretario Generale del Partito Comunista Italiano, Luigi Longo, saliva sul palco di Messina per un comizio che oggi appare come un vero e proprio manifesto a favore dell’opera. Longo definì il Ponte “certo cosa utile”, sancendo il favore ideologico del PCI per l’intervento statale e la grande opera infrastrutturale come motore di sviluppo del Sud, in linea con l’ortodossia marxista-leninista che vedeva nella pianificazione centrale l’unica via per risolvere la Questione Meridionale. Tuttavia, in questa accettazione, si nascondeva una strategia politica tagliente, un esempio di come il PCI trasformasse ogni progetto in una lotta etica e morale: il leader comunista pose infatti un veto lapidario, affermando che a costruire il Ponte non dovessero essere “i dc della frana di Agrigento”, con il riferimento esplicito al crollo del 1966, simbolo del malgoverno clientelare e della speculazione edilizia, affermando che l’opera andava sottratta a questa logica predatoria. Vi era inoltre il timore espresso lucidamente che il Ponte potesse servire soltanto a far emigrare più facilmente altri siciliani, anziché generare ricchezza in loco, un rischio che rendeva l’opera accettabile solo se inserita in una più vasta e risolutiva programmazione economica statale.
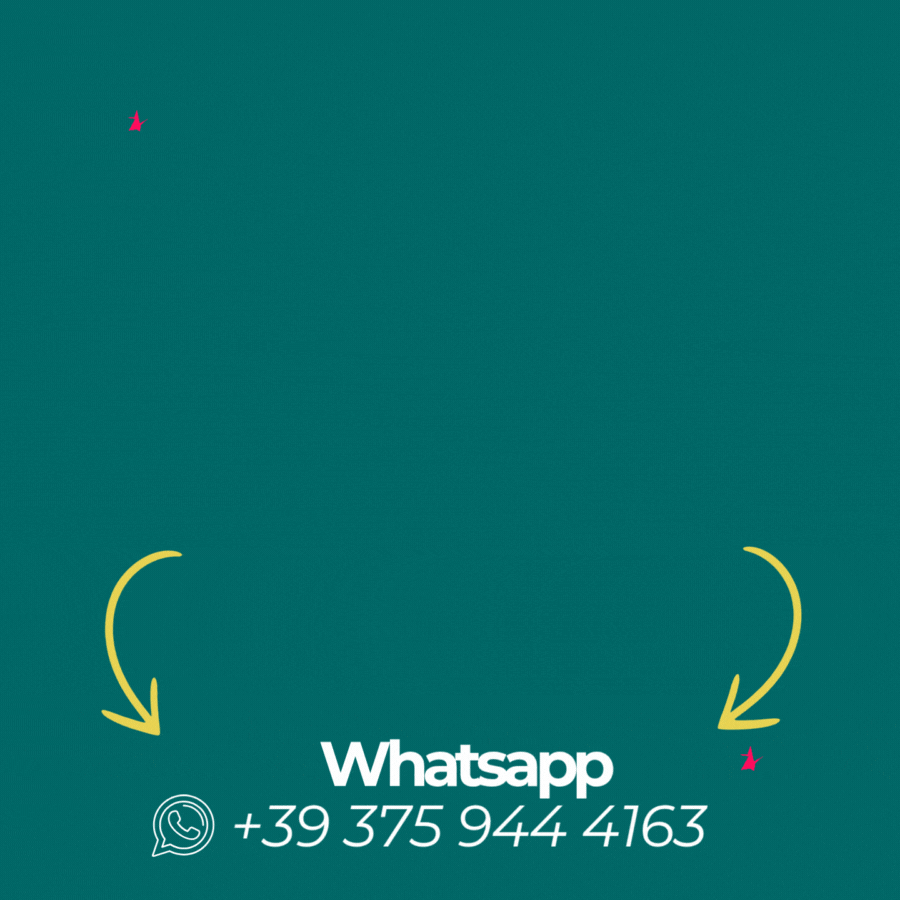
Il favore del PCI, così ideologicamente condizionato e incentrato sul gigantismo statale e l’onestà politica, non resse alla prova dei decenni successivi. Il passaggio dal fronte del Sì a quello irriducibile del No Ponte che oggi anima la linea del Partito Democratico è il risultato di un profondo mutamento: con la crisi economica degli anni Settanta, l’idea della “Grande Opera” perse smalto, e l’attenzione si spostò dal principio ideologico dell’intervento statale al pragmatismo economico, trasformando l’opera in un costo mostruoso e insostenibile, assorbendo risorse più utili al potenziamento delle infrastrutture esistenti (ferrovie, porti, viabilità interna) in Calabria e Sicilia. In parallelo, l’emergere delle tematiche ambientali negli anni Ottanta e Novanta fornì una nuova e potente chiave di lettura, e il Ponte mutò di significato, trasformandosi da simbolo di progresso a vessillo di cemento e aggressione al territorio, denunciando l’impatto sul paesaggio e la fragilità sismica dello Stretto. Infine, con il crollo della Prima Repubblica, la critica al clientelismo si trasformò in una condanna totale della speculazione, e il Ponte fu definitivamente marchiato come potenziale polo di attrazione per le infiltrazioni criminali e di spreco di denaro pubblico.
In sostanza, la sinistra è passata dall’esaltare l’opera di ingegneria come strumento per il socialismo al denunciarla come strumento del capitalismo predatorio e corrotto: questa transizione è la cartina di tornasole di come l’ideologia, in Italia, abbia saputo trovare nuove vesti per giustificare le scelte politiche, dimenticando il suo stesso passato interventista. In questo ribaltamento, il fronte politico ha trovato una nuova bandiera ecologista e anti-speculativa, ma ha rinunciato alla sua originaria e dogmatica vocazione a fare, abbracciando una filosofia più cauta, votata al limitare e al conservare.
(Domenico Mazza)