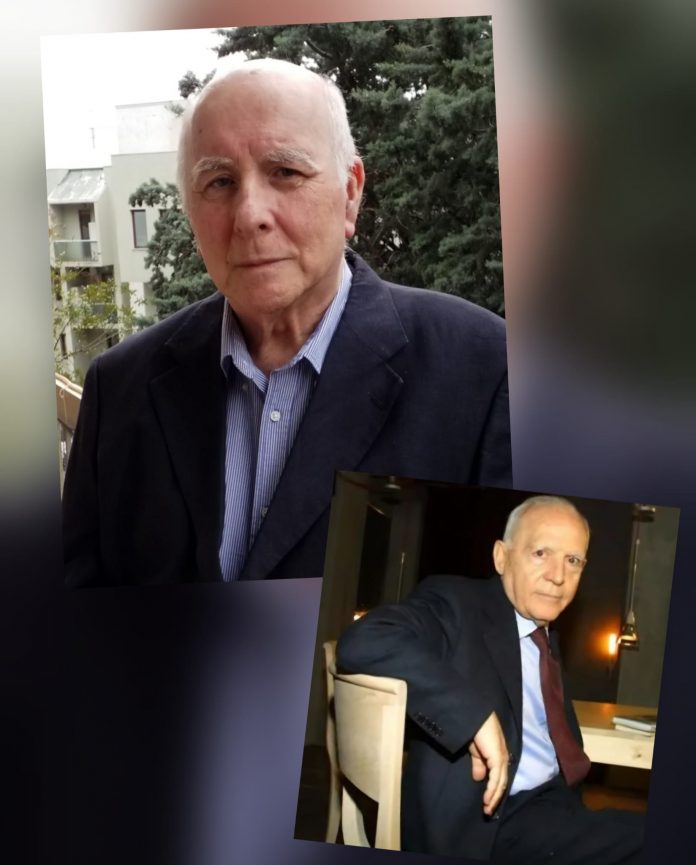Dedicato a Vincenzo Consolo, nell’incontro con gli studenti del Liceo Classico “Valli” di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)
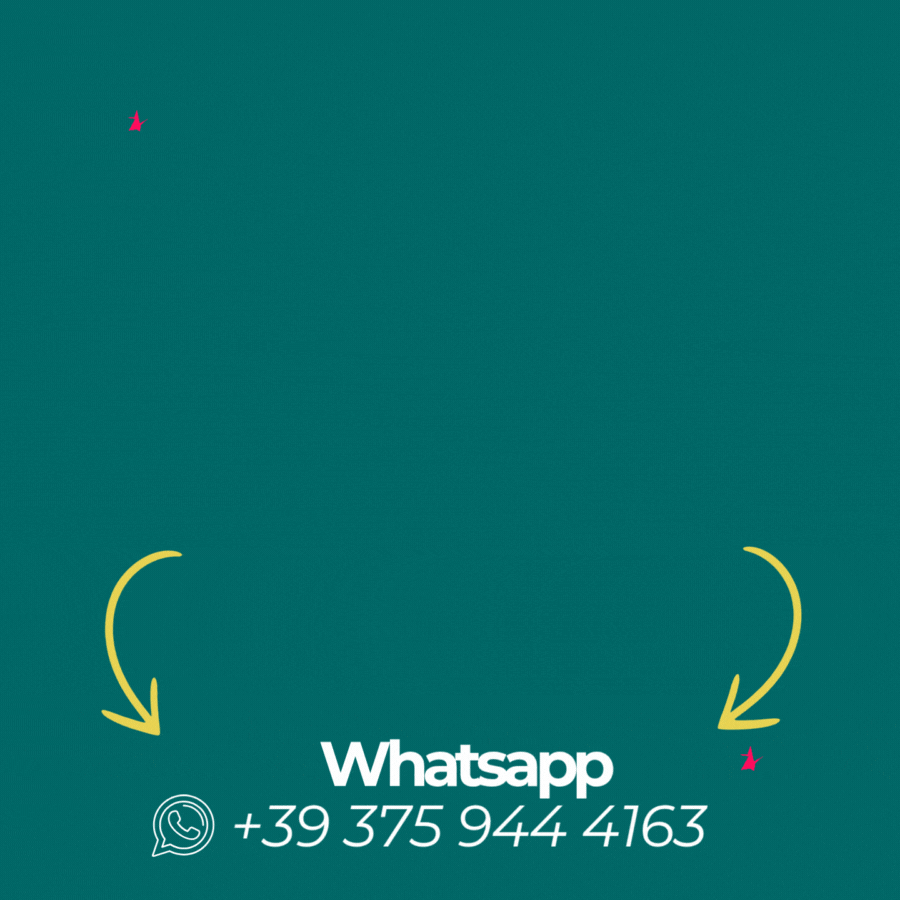
IL LICANTROPO E LA LUNA
La teca verde dei Nebrodi
In cui fermentò il sangue e la speranza
della rorida ferita dell’aprile,
l’aorta frastagliata d’arenaria
con il santuario proteso ad inghirlandare
il seno della pomice e del cielo,
carrettieri, zolfatari, piscaturi,
femmine nere, picciotti disperati
fenici, greci, normanni e saraceni,
angioini pupari, santi banditi e verdurai,
ombre misteriche, fantasmi innamorati
scintillanti nel mattatoio delle zagare.
Licantropi che abbaiano alla luna
l’oro, le arance, il viola
distesi sui guanciali dell’azzurro
che tra scaglie palpitanti modula,
con le ombre metafisiche e i misteri,
“tra gli argini di malta e sabugina”,
cercò una incandescenza d’aria,
fuggito dalla maniacale febbre
dell’Urbe metallica e sconvolta
da frastuoni e veleni nel respiro.
Peregrinavi per luoghi incisi
nel battito del cuore,
dove un tempo sognavi il paradiso
Militello, Capo d’Orlando, Barcellona,
Milazzo ubriaca di ciclamini,
Villa Piccolo, la frescura ossigenata
Nebroidea, dove il tuo piede affonda
nel silenzio catacombale che tu aneli
dopo Pantalica, Villa del barone
che a cinquanta anni scoprì dentro di sé
l’anima frondosa del barocco,
Racalmuto, Sciascia, Nino Pino,
inseguivi il sogno del ritorno tra i cari amici
che giacevano nel cuore
e dentro gli ipogei della tragedia,
Tu, con la bufera delle sillabe,
calde di onde, di suoni, di memoria,
prigioniero di Lunaria e riottoso del potere,
scandivi nel diuturno esilio
i riti blasfemi dei baroni e dei Vicerè,
reclusi in follie di possesso,
squarciati dalla perdita dell’Essere
e penzolanti al ramo dell’Avere.
Una lunga catena di amore e di odio,
di ferocia, di riscatti inesplosi, di sterminio.
A marzo nel tepore della notte
subliminata da mandorle e viole
dalle viscere infrante del Vulcano
brillano le luminarie a Salvatesta
risucchiate nel biviere di Alfarano
pronte a riesplodere sui lidi del Tirreno
nelle ferie d’agosto,
e rivoli di porpora ingrottati
straripano nel calice del Sole
a seminare eccidi sull’asfalto
per l’uva ,i pascoli, il sentiero,
per l’oro giallo, bianco e nero
Bronte, Mylae, Termini Imerese,
Fantina, Ragusa, Villafranca
Comiso, Melilli, Gibellina,
Mandrazzi dove nelle orge di vento
che aggredisce e sibila nel vuoto
come un lacerante urlo della storia,
tra tetti e imposte mutilati,
dove il Sud sognava di poter risanare
un vasto terreno abbandonato
e vivere in pace e in libertà
nel confortante fiato familiare.
Ora quell’Eden subliminare,
è spesso squarciato
dal lungo boato del cratere in fiamme
e non c’è più Polifemo a far da palo
agli umani che brancolano nel fuoco
sempre acceso nell’immenso vuoto,
appeso alle chele del Vulcano
che ospita nidi di ciaule e di gufi
immobili negli anni
attendono l’eco di un passo umano
per poter fuggire lieti
oltre le arroventate nubi,
consapevoli di aver atteso un’ombra invano.
Alla stazione nella notte stralunata
il proscritto vagola su selciati ignoti
dove si frangono
i laceranti concerti dell’addio
dentro celesti cupole di libertà perdute,
mentre nell’anima straziata
vibra dentro piaghe violentate
la fragranza del pane dell’infanzia
e il licantropo squarcia le ansimanti ombre
-il fiato appeso al corno della luna-
con lo strozzato urlo dell’ucciso.
Ora il tempo inanella tra le dita
la necropoli dei vivi di Bafia
dove dentro le labbra spente delle mura
sfavillano incaute perle di speranza,
in attesa del precipizio dell’aurora
dalle muschiose fessure delle Rocche
merlate, sentinelle sull’abisso
tra Passo dei Lupi e Pizzo Garamante.
Tu, ora emerso dai gorghi di Plumelia,
con la fiaccola dentro l’alveo della mente
ti inoltri vacillando nel mio abbraccio
dentro le squillanti reliquie della storia
dove ancora ansimano nel cranio di pietra
gli echi mistici dei riti del Bosco
e mi sospinge con le tue creature
tra i lemuri superstiti del tempo
di questo nuovo secolo sospeso
alla ragnatela di ori ripugnanti
e mi chiedi notizie
di Filippo Damante
dell’Orante, du Muzzu, di ‘Nzunzù
delle favole antiche e delle streghe
che popolarono le laiche chiese e i querceti
che ancora denudano radici
alle sorgenti del Longano e all’Acqua Santa.
Tu mi chiedi, ansioso e disperato, del dio
di quale dio confortò il dolore
di queste anime morte, seppellite
sotto la nuda gleba di Piscopo,
dove ancora “Nottetempo casa per casa”
i piccoli falò fremono
di silenzio, di pianto e di preghiera
per le stragi che i demoni
dei forni crematori compirono
con il fuoco della cera umana
che insanguinò l’Europa
e che ora altri mostri del potere
vogliono seppellire per sempre
con invisibili virus alleati.
Qui, arresi tra le mura,
nella tregua ai piedi del Maniero
i disertori con un’ inestinguibile paura
cercano un rifugio sicuro dal terrore
per sentire prosciugato anche il sangue
nelle vene arse
tra ululati di sogni ed agonia
I semi incandescenti della parola
pietrificata nella malta e nel pantano,
dove solo le conchiglie lucescenti
si sottraggono alle menzogne della notte
restando in apnea invisibili nel fango,
in attesa che le ronde della morte
varchino l’implacabile furore di Acheronte
e le anime morte possano risorgere
nell’abbagliante teatro azzurro del cielo.
Ora che immensi funghi atomici
aggrediscono con nuvole nere
la visione di uno spiraglio di vita
ora tu cerchi tra gli avelli
con la luminescente cecità di Omero
un flebile alito del cuore
che possa ridestare altra vita
per cancellare anche il ricordo
della violenza, dell’insania e dell’orrore
con la dolcezza della parola ripiumata.
E Voi,
nuovi credenti della sacerdotessa Artemide
che vento e tempesta vi sospingano
verso i sarcofaghi porosi di Pantalica
a ritessere il velo delle Grazie,
mentre veleggiate
tra gli imenei zigrinati del sapere,
non voltatevi indietro;
la città di Dite si gretola
dentro altri roghi di nubi tossiche,
e il pianeta già colmo di veleni
mostra segni incontrollabili
di agonia nel pianto delle statue
nelle epifanie rivelate a bimbi puri,
in tutti quelli che piangono
e nell’animo ardono della tua carezza melica,
nuovo Orfeo siciliano,
dolce cantore di felici memorie e di miti.
Predatore salvifico di simulacri mitici,
stritolato un tempo anche tu
dall’empia diaspora del corpo dentro l’anima,
Ti resti vergine nella parola melica
l’isola perduta dell’infanzia,
inebriata dal fiume delle zagare
avvolta nell’afrore del basilico-
Già sul tuo etereo mare
che ha ingoiato i tuoi occhi innamorati,
piovono le scintille limpide
di una nuova alba. I pesci già balzano
in geometrie d’amore. L’Orsa è tornata
a disegnare nel celeste velo
le perfette geometrie di un tempo,
il pescatore con le reti è sul molo
pronto e lieto di poter ripescare
il senso prezioso del lavoro,
la gioia perduta della vita.
CARMELO ALIBERTI