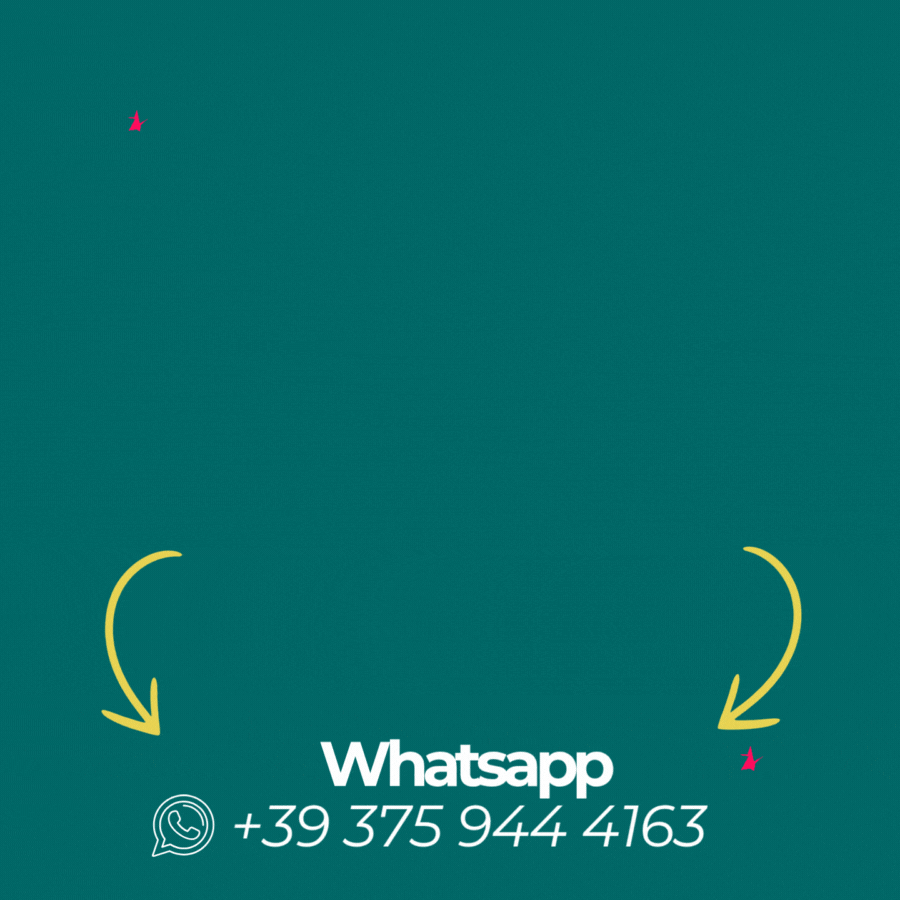Il sale ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita e da sempre è sinonimo di ricchezza tanto da essere usato, nel linguaggio comune, per definire gli uomini intelligenti come persone aventi “sale in zucca”.
Ha funzione regolatrice, influisce sulla pressione dei sistemi liquidi, facilita la conduzione elettrica, è un conservante naturale, è fondamentale per la biologia umana e animale, ostacola il congelamento delle acque e dà gusto ai cibi. In passato è stato anche utilizzato al posto del denaro: i soldati romani venivano pagati in sale (da qui il termine salario). Non tutti i sali sono uguali e non tutto il sale è uguale a sé stesso. È una miscela di componenti più o meno variabili in funzione della fonte d’origine e dei trattamenti a cui è sottoposto. La primissima differenza è tra sale marino e salgemma. Rispetto al sale marino, il salgemma ha composizione legata ai luoghi di formazione del giacimento. Questo si ottiene per estrazione diretta dalla roccia mentre il sale marino è ottenuto per evaporazione dell’acqua di mare dopo un’opportuna serie di stadi lavorativi che lo rendono “alimentare”. Dettagliamo meglio tale ciclo produttivo. Immaginiamoci in provincia di Trapani, all’interno di in una salina dove ancora oggi il sale viene estratto manualmente. La prima cosa che salta all’occhio sono le larghissime vasche, camere inondate di acqua di mare la cui minima profondità è funzionale ad una “rapida” evaporazione dell’acqua e concentrazione del sale. L’aspetto affascinante di questa tipologia di produzione, a mio parere, è la dimensione spazio temporale: il processo di estrazione ha la durata di un semestre circa e impegna spazi grandissimi. Prima di andare avanti, partiamo dalla composizione dell’acqua di mare: in ogni litro mediamente si possono pesare circa 35 g di sali di cui: cloruro di sodio per 27 g (77.1 %), cloruro di magnesio per 3.8 g (10.8 %), solfato di magnesio per 1.6 g (4.6 %), solfato di calcio per 1.2 g (3.4 %) e solfato di potassio per 1 g (2.9 %) e altri a chiusura del bilancio.
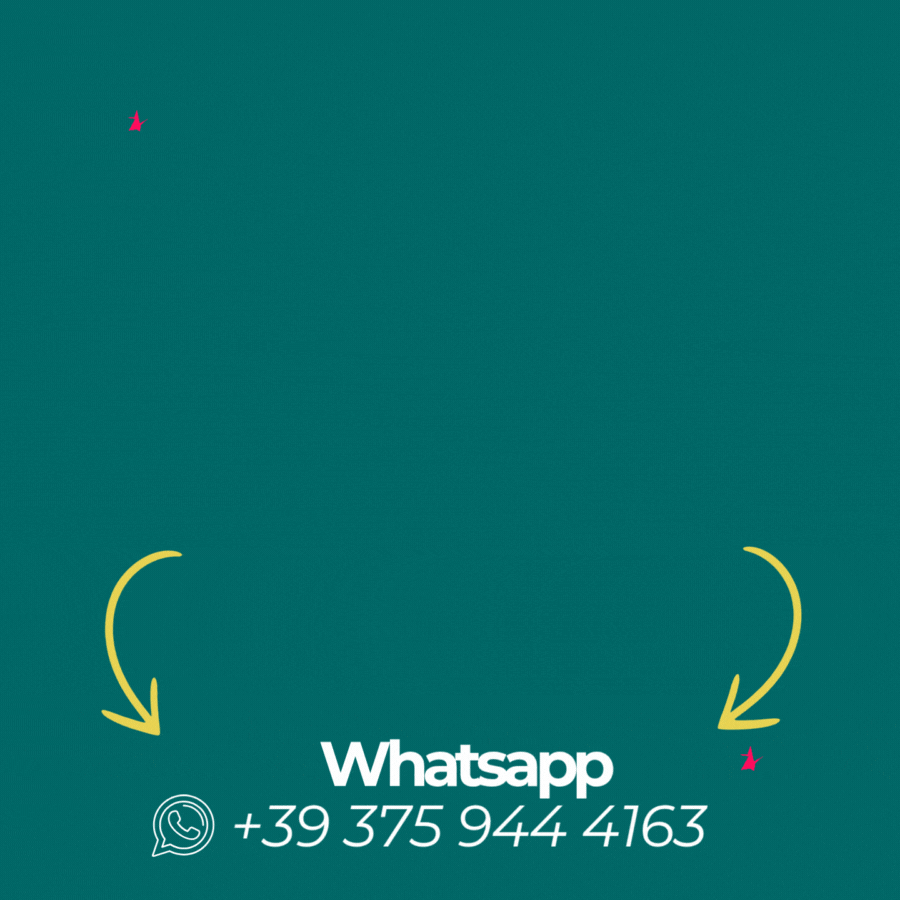

Tale composizione non rispecchia ancora quella del sale da cucina che è ancora più ricca in cloruro di sodio. Ciò significa che per concentrare il cloruro sodio occorre ridurre/eliminare gli altri sali. La chimica ci dice che ogni sale ha una propria solubilità in acqua al di sopra della quale precipita. Evaporando l’acqua, per effetto dell’irraggiamento solare, si ha concentrazione di tutti i sali contenuti che cominceranno a precipitare separatamente e con un ordine ben definito dettato dalla loro solubilità. Nell’ordine si avrà la seguente sequenza di precipitazioni: ossido di ferro, carbonato di calcio (calcare), solfato di calcio (gesso) e, infine, il cloruro di sodio.bDetto ciò, esaminiamo le varie fasi del processo di produzione del sale marino cominciando da:
Evaporazione: l’acqua di mare, detta acqua “vergine”, viene introdotta nei primi bacini dove comincia ad evaporare e a concentrarsi.
Concentrazione: l’acqua viene spostata in successive vasche di concentrazione dove l’acqua continua ad evaporare. Qui si ha la precipitazione dei sali dal meno solubile in avanti fino a lasciare in soluzione il solo cloruro di sodio. La salamoia perde così gli ossidi di ferro, il calcare e il gesso.
Cristallizzazione: l’acqua ormai satura di sale, raggiunge l’ultima vasca detta “salante” trova le condizioni per la separazione del cloruro di sodio contenuto che cristallizza precipitando sul fondo della vasca.
Raccolta e accumulo: il sale precipitato viene raccolto manualmente o meccanicamente ed accumulato all’aperto in modo da consentire la perdita dell’umidità residua ancora contenuta.
Lavaggio ed essiccazione: il sale ora anidro o, meglio dire, con umidità minima, viene trasferito alla fase di lavaggio dalle impurità che avviene con acqua satura (di sale); il lavaggio è seguito da una seconda essiccazione magari attraverso l’uso di macchinari progettati allo scopo.
Vagliatura: all’essiccazione segue poi la separazione dei cristalli per dimensioni. Il sale attraversa dei vagli che definiscono la granulometria del prodotto.
Iodatura: è l’ultimo step prima del confezionamento e distribuzione.
Descritto il processo, passiamo al prodotto che troviamo sugli scaffali della distribuzione perché occorre fare distinzione, oltre che tra sale marino e salgemma, quanto meno tra sale raffinato, integrale e fior di sale.
Il sale raffinato è decisamente bianco, è molto puro in termini di cloruro di sodio e spesso è addizionato di antiagglomeranti, sostanze permesse e regolamentate dalla legislazione, che consentono di limitare l’assorbimento dell’umidità (il sale è naturalmente igroscopico) mantenendo separati i granelli.
Il sale integrale è meno bianco, più ricco di sali di potassio, iodio e magnesio naturalmente contenuti nella fase di produzione e non eliminati. É più umido del sale raffinato e quindi meno uniforme nei grani in quanto solitamente privo di additivi.
Il fior di sale è invece un sale marino che, avendo una diversa composizione, cristallizza naturalmente e in assenza di vento, sulla superficie delle vasche in “fogli” sottilissimi (qualche millimetro). È ricco in magnesio, calcio e potassio. Ha struttura fragile e viene raccolto manualmente nelle ore fresche della giornata. È definito anche “caviale del sale” per la sua piccola produzione, la consistenza, il suo sapore delicato e privo di retrogusto amaro. Risulta perfetto per la produzione di dolci e piatti gourmet.
Fin qui tutto bello ma occorre tenere presente che a differenza del salgemma, i cui bacini minerari si sono formati millenni addietro, i mari di oggi purtroppo sono soggetti ad inquinamento ed in particolare all’accumulo di microplastiche che, oltre a provocare danni all’ecosistema marino, potrebbero entrare nella catena alimentare umana anche attraverso il sale. Sia chiaro, non intendo insinuare dubbi sulla salubrità di questo alimento ma, noi umani, dobbiamo sempre ricordarci che ogni nostro gesto porta con sè la responsabilità del mantenimento dell’ambiente terrestre e della salute degli esseri che lo vivono, pertanto, qualunque cosa facciamo, facciamola “cum grano salis”.
(Giovanni Gargano)