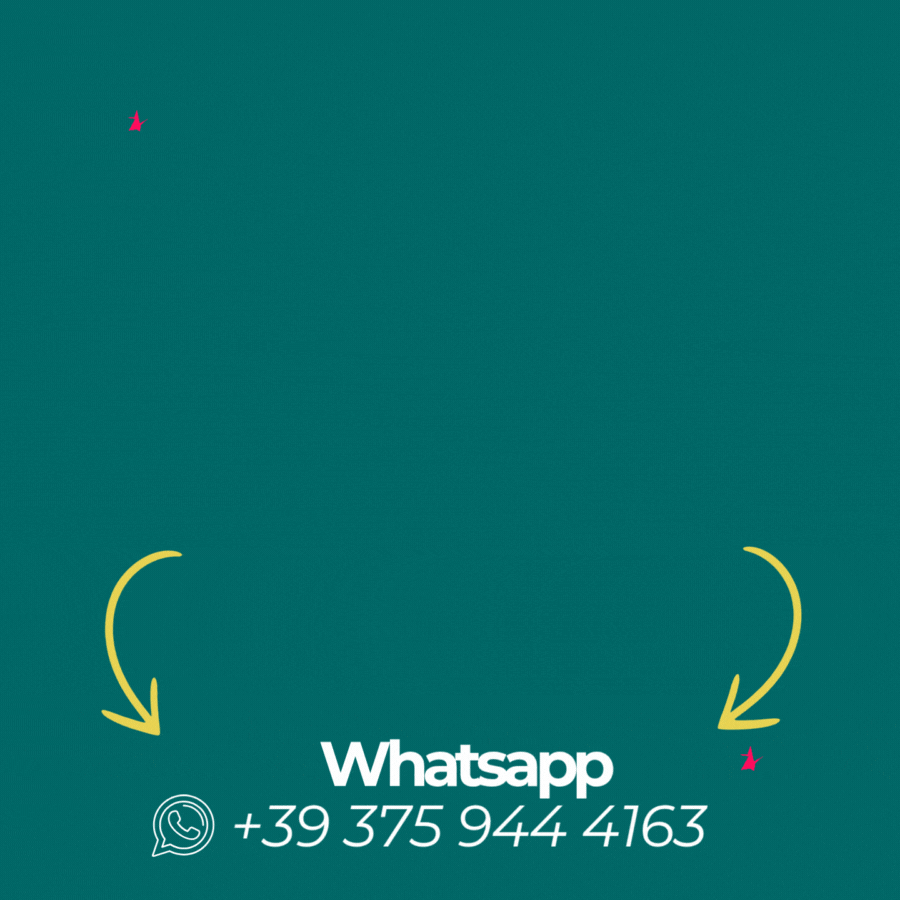La democrazia, sin dalle sue origini nell’antica Atene, si fonda su un principio tanto semplice quanto rivoluzionario: il coinvolgimento diretto dei cittadini nelle decisioni che riguardano la collettività. In quel primo modello, le assemblee popolari erano il luogo in cui si decideva su guerra, pace, leggi e giustizia. Non esistevano rappresentanti: ogni cittadino partecipava in prima persona. Oggi, nella realtà della democrazia rappresentativa, e in particolare nel contesto italiano, questo modello diretto è stato ampiamente sostituito dalla delega. I partiti, attraverso il meccanismo delle liste bloccate, scelgono i parlamentari, riducendo il margine di intervento diretto dei cittadini.
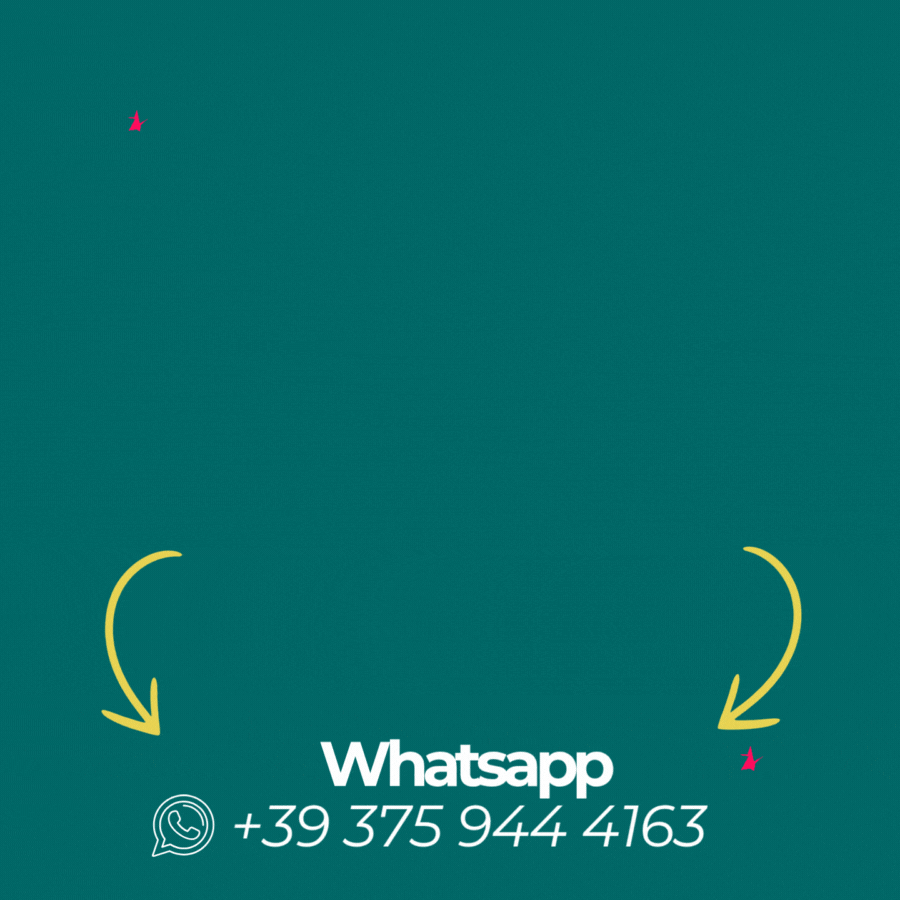
In questo scenario, il referendum resta uno dei pochi strumenti che ancora consente una partecipazione popolare autentica, richiamando simbolicamente quelle radici ateniesi. Il referendum è, o dovrebbe essere, un momento alto della vita democratica: un’occasione in cui il popolo non delega, ma esercita direttamente la propria sovranità su questioni fondamentali.
Ma questo presuppone una condizione essenziale: la partecipazione. I referendum abrogativi sono infatti soggetti a quorum, una soglia minima del 50% più uno degli aventi diritto al voto, necessaria per rendere valido il risultato. Un meccanismo pensato per garantire che le decisioni non siano frutto della mobilitazione di una minoranza, ma espressione di una volontà davvero collettiva.
Eppure, negli ultimi anni, la partecipazione ai referendum è crollata. Molte consultazioni sono state invalidate per il mancato raggiungimento del quorum, trasformandosi in occasioni mancate e alimentando un circolo vizioso di disillusione e disimpegno. In questo contesto, si è aperto un dibattito sempre più acceso: l’astensione è una forma di protesta consapevole o la conferma di una crisi strutturale della nostra democrazia? A differenza dell’antica Atene, dove chi non partecipava alla vita pubblica era considerato idiōtēs cioè inesperto o disinteressato verso il bene comune, oggi l’assenza dalle urne è vista come una scelta legittima. Ma è anche il sintomo di una sfiducia crescente nei confronti delle istituzioni e della classe politica, incapace o non più interessata a coinvolgere i cittadini in modo trasparente e credibile.
Al tempo stesso, l’astensione è divenuta una strategia politica sempre più utilizzata. Non solo da parte di un elettorato deluso, ma anche da partiti e movimenti che invitano esplicitamente a disertare le urne per far fallire il quorum e bloccare una consultazione il cui esito non sarebbe a loro favore. Una tattica formalmente legittima, ma che solleva interrogativi profondi sulla qualità del confronto democratico e sul senso di responsabilità collettiva.
Alla vigilia di un nuovo referendum, con partiti divisi tra sostenitori, oppositori e promotori dell’astensione attiva, è importante fare chiarezza. L’astensionismo può presentarsi in diverse forme: la più diffusa è semplicemente non recarsi al seggio; le altre, più tecniche, sono il rifiuto della scheda elettorale dopo l’identificazione o la sua riconsegna senza entrare in cabina. Nel primo caso, l’elettore non risulta conteggiato ai fini del quorum; nel secondo, il voto è nullo ma incide sul raggiungimento del quorum. Oggi si parla molto del rifiuto della scheda, ma questa pratica non è nuova: è stata usata da forze politiche di ogni orientamento, con fortune alterne, come strumento tattico e simbolico.
In questo clima politico polarizzato, ricordare su quali basi si fonda la nostra democrazia, e comprendere fino in fondo il significato delle diverse forme di partecipazione e astensione, è un atto di responsabilità. Ogni gesto, che sia un voto, un’astensione o un rifiuto consapevole è una scelta politica. E in un contesto in cui il rischio maggiore è l’indifferenza, recuperare il senso della cittadinanza attiva è fondamentale. Non si tratta solo di dire sì o no a un quesito referendario, ma di decidere che tipo di democrazia vogliamo costruire.
Il nodo vero, oggi, non è schierarsi a favore o contro il quorum, ma restituire significato alla partecipazione politica. Perché se è vero che il potere appartiene al popolo, è altrettanto vero che questo potere esiste solo se il popolo sceglie di esercitarlo. E farlo davvero significa esserci, capire, scegliere. In un tempo in cui la politica sembra distante, il referendum è l’occasione per riavvicinarla. A noi spetta decidere se coglierla o meno.
(Ivan Pantano)