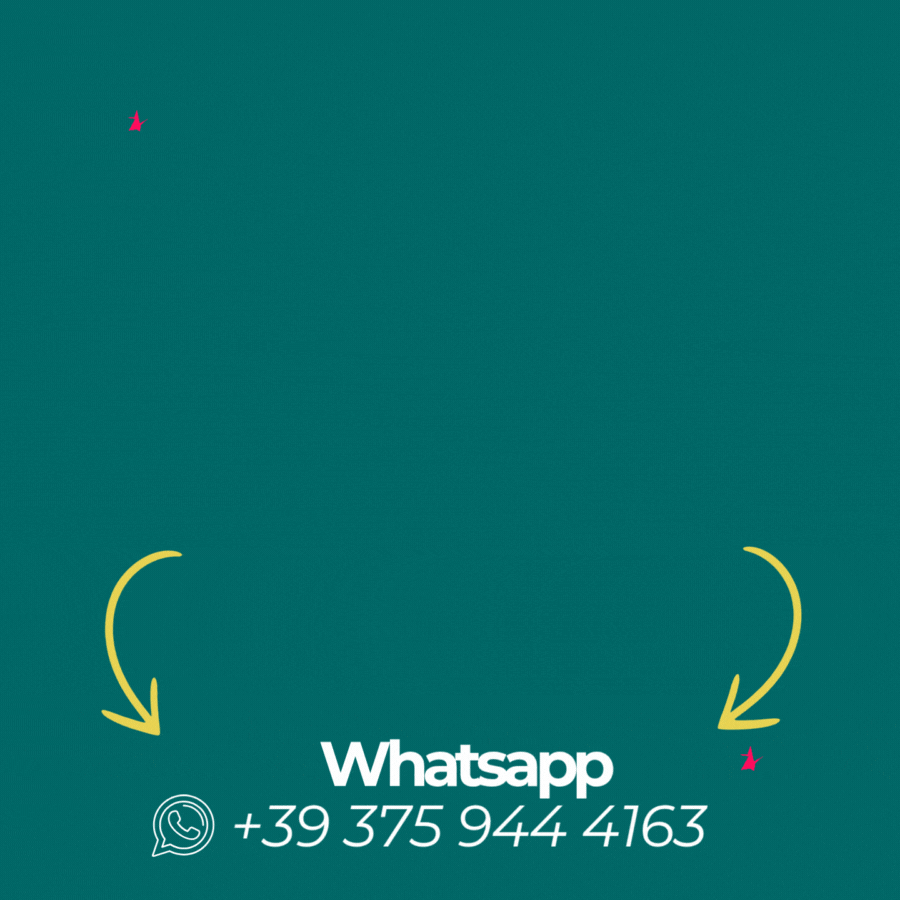Educare alle emozioni nelle scuole potrebbe prevenire la violenza? Le cronache continuano a raccontarci una continua escalation di episodi violenti che, in particolare tra i giovani, è spesso legata alla mancanza di educazione emotiva e all’incapacità di gestire le emozioni.
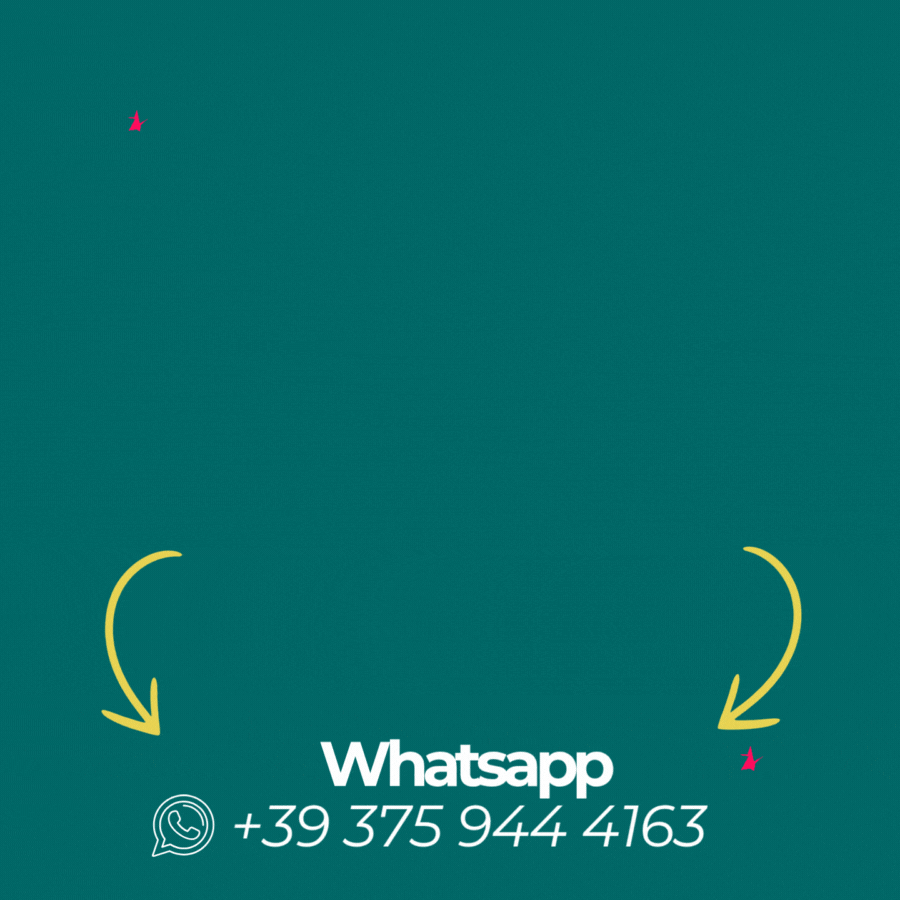
La letteratura scientifica (Goleman, Gottman, Mariani, Schiralli) è infatti concorde nel ritenere che l’aumento delle competenze emozionali rappresenti il più efficace fattore di protezione per evitare la maggior parte delle forme di disagio e di dipendenza patologica (tossicodipendenza, anoressia, bulimia, dipendenza da Internet, alcolismo, ecc…) in età adolescenziale. L’intelligenza emotiva, infatti, rappresenta la capacità di un individuo di identificare, differenziare e gestire le proprie emozioni. Essa svolge un ruolo fondamentale nell’empatia e costituisce un mezzo efficace per contrastare attivamente la violenza.
A fronte di un’opinione pubblica sempre più disorientata, gli esperti assicurano che l’educazione emozionale possa aiutare a prevenire la violenza, poiché ci insegna a informarci sul perché proviamo rabbia in determinate situazioni. Daniel Goleman, docente di psicologia all’Università di Harvard ha scritto negli anni Novanta il saggio Emotional intelligence notando come gli insegnanti cominciassero “a capire che esiste un diverso tipo di lacuna, assai pericolosa: l’analfabetismo emozionale” e se l’istruzione “deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali” (come recita l’articolo 26, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti umani), non può essere limitata al solo insegnamento dell’educazione civica.
È importante ricordare che, proprio sull’onda di un dibattito pubblico seguito ad episodi di cronaca, all’inizio del 2022 è stata approvata, all’unanimità, la Legge 2782/22, che disciplina la «Disposizione in materia di insegnamento sperimentale dell’educazione all’intelligenza emotiva nelle scuole di ogni ordine e grado». Nel testo il legislatore ribadisce che lavorare in classe su emozioni e sentimenti serve a promuovere il successo formativo; prevenire la povertà educativa; contrastare la dispersione scolastica. L’orientamento normativo italiano è in linea con la tendenza internazionale che vede, per esempio, l’istituzione di un Ministero per la Solitudine, sia nel Regno Unito sia in Giappone. Parallelamente, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha istituito una commissione per promuovere la connessione sociale.
Favorire la consapevolezza, l’alfabetizzazione emotiva e una rete di sane relazioni sociali è una priorità di salute globale, con importanti risvolti anche da un punto di vista sociale ed economico. Infatti, partendo dalla constatazione che il mondo digitale è anaffettivo, è necessario curare di più i rapporti umani (e reali), imparando ad instaurare relazioni sicure e solidali, le quali già di per sé costituiscono una forma di prevenzione della violenza. Le nuove generazioni che vivono il tempo del prevalere della tecnologia nella comunicazione quotidiana, si trovano sprovvisti di strumenti interiori adatti.
Questo problema ha ripercussioni significative in diversi ambiti della vita sociale e lavorativa, con impatti notevoli sulla salute mentale e sul benessere generale degli individui. Per questo è essenziale un’educazione emotiva, in particolare nelle scuole, per insegnare ai bambini e alle bambine che è estremamente importante comprendere quello che si prova, ad approcciarsi con l’altro e con sé stessi in modo comprensivo e avalutativo, perché è necessario rispettarsi e accogliersi come esseri umani.
(Giovanna Riccardo)