archivio discontinuo
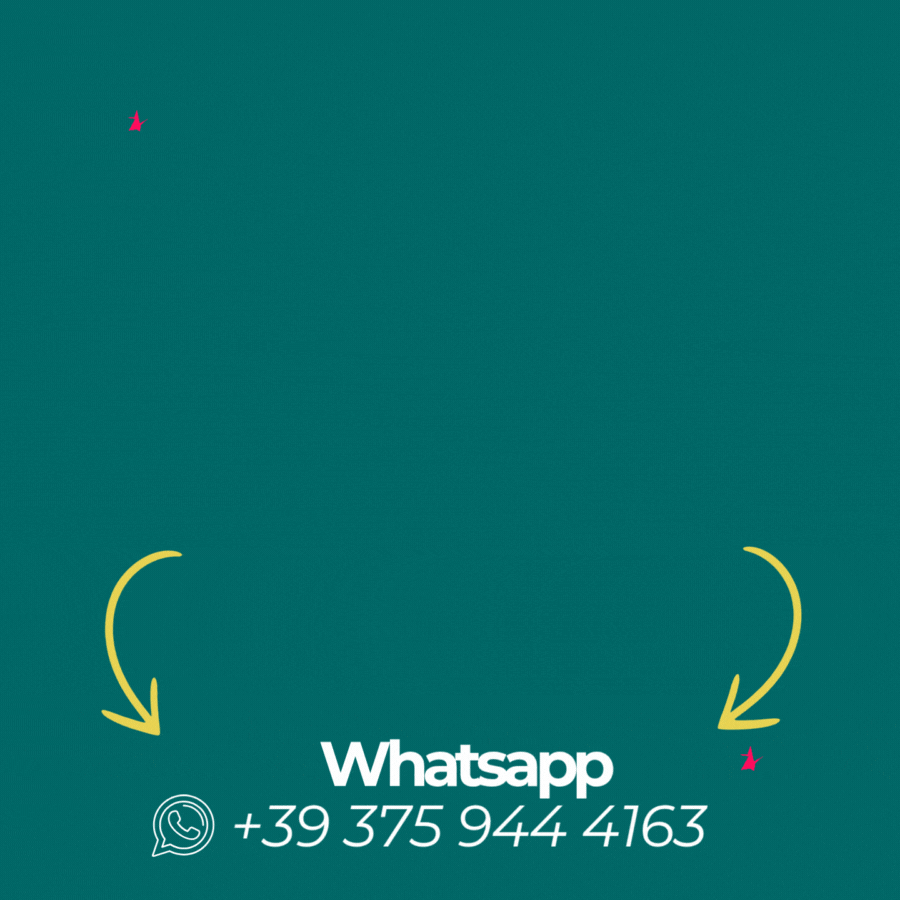
È un ciclo di mostre che mette insieme le opere collezionate durante le quattro edizioni della residenza “Discontinuo / an open studio” (2018-2021) al termine dal quale ogni artista partecipante ha donato un’opera da custodire nel nostro spazio di creazione e aggregazione: Discontinuo!
Qui è dove accade tutto, uno spazio che mantiene i segni del passato storico e di quello artistico.
La Vetrina, con la serie di mostre “Archivio” mette in dialogo lo spazio con il fuori. Che siate residenti o di passaggio nella città potrebbe capitarvi di attraversare Vicolo I Mandanici e restare sorpresi dalla presenza di una finestra su questo mondo altro, sospeso, che invita a restare.

la stanza di Alessio
Alessio Barchitta
Estratto dal testo curatoriale redatto durante la quarta edizione della residenza Discontinuo.
La stanza di Alessio è un altare, luogo ideale di rappresentazione del sacro, spazio in cui l’artista mette in scena i contrasti semantici di questo concetto: sacro come sacrificio, come simbolo di una comunità, come fatto storico inalterabile, come veicolo di fede. Ma il sacrifico porta con sé, oltre che l’idea di purezza, l’inevitabilità della morte, la paura della debolezza, la profanazione dell’ideale.

Le opere a cui facciamo riferimento sono il frutto della residenza Discontinuo #3 in cui torniamo a parlare di sacralità. La ricerca dell’artista mira sempre a palesare la vera natura delle cose per contrappasso, attraverso manufatti esteticamente riconoscibili, gradevoli ai sensi, attraverso ambienti immersivi, da cui si esce con un vuoto, con una domanda. Il putto e l’ala poggiati su cuscini dal colore funereo che abbiamo scelto di esporre in vetrina sono chiaramente legati all’ambiente clericale e, più in generale, all’idea di monumento in quanto simbolo dell’infallibilità divina e della sovranità umana. Eppure queste due parti anatomiche del voluttuoso putto, smembrato e sospeso, sono realizzate in guano di piccione, scarto e condanna di qualsiasi monumento pubblico o luogo abbandonato.

Tu hai un rapporto speciale con Discontiuno dal momento che qui è anche il tuo atelier. Ma sei anche abituato alle esperienze di residenza altrove. Come vivi questo “ritorno a casa”?
Credo fortemente nella condivisione. Io ho avuto la fortuna di ricevere in dono questa casa di famiglia e vederla animarsi attraverso la presenza di altri artisti mi fa felice e rende ogni ritorno diverso perché la casa si trasforma con le persone che la abitano. Questo è uno spazio semplice, che attiva la creatività ed è uno spazio che sa ascoltare. Non mi stanca mai anche se richiede cura e dedizione costanti. Le residenze sono momenti fecondi in cui ho la possibilità di conoscere e confrontarmi con altri artisti grazie alla quotidianità condivisa. Spesso questo scambio permette di comprendere un lavoro meglio di quanto non faccia un testo curatoriale per questo documentare ciò che succede in residenza e realizzare un archivio è stato importante da subito. Qui il contesto gioca un ruolo fondamentale: non essendoci un’impostazione commerciale e trovandoci in un territorio distante dal sistema dell’arte contemporanea, non vi è “inquinamento visivo”. Per questo la sensazione, ogni volta che ospito artisti, è che la produzione risulti più libera e autentica. Anche quando sono qui a lavorare in altri periodi dell’anno non sono mai completamente solo: la porta del mio studio è sempre aperta, entrano amici, vicini, curiosi; si chiacchiera, talvolta mi danno una mano. Per me è una condizione necessaria.
La partenza lascia sempre un po’ di amaro in bocca: immagino cosa potrebbe diventare questo luogo se potessi portarlo con me a Milano, dove vivo. Ma so che è giusto che resti qui, che viva in un tempo dilatato, che si lasci attraversare e che poi, a distanza, torni ogni volta a farsi desiderare.
Che rapporto ha la tua ricerca con il sacro?
Il sacro mi appartiene, mi si attacca addosso. Lo affermo perché vivo quotidianamente il sacro siciliano in molteplici forme e situazioni. Cerco, nel mio piccolo, di contribuire a preservarne quell’aura capace di unire folle intere, al di là del credo religioso: un tratto culturale profondamente meridionale. Inevitabilmente il mio lavoro ne risente oscillando come un’orbita ellittica che talvolta si avvicina e talvolta si allontana da esso. Il sacro è spesso paradossale e contraddittorio e questa ambiguità si riflette anche nella mia ricerca. Quando, ad esempio, ci si trova immersi in una folla di fedeli che celebrano con devozione una santa venerata da secoli diventa difficile distinguere con chiarezza il confine tra sacro e profano. Quello che resta evidente è però la forza del coinvolgimento collettivo: autentico, totale. Tutto il dispositivo ritualesi organizza intorno al soggetto sacro e, nel caso delle reliquie, la distanza tra chi venera e ciò che viene venerato diventa quasi impercettibile.
Il recupero e l’utilizzo di materiali di scarto è alla base del tuo metodo. Perché hai scelto questo materiale e come nasce una tua opera?
La questione della distanza è per me centrale. Ogni volta che realizzo un manufatto per affrontare un tema, inevitabilmente si crea uno scarto tra la questione e chi osserva. Il mio intento è ridurre al minimo questa distanza, scegliendo materiali il più possibile prossimi alla questione trattata. L’uso di materiali di scarto nasce proprio da questa esigenza: spesso lo scarto è già parte integrante del problema stesso. In questo lavoro ho scelto il guano perché rappresenta concretamente e simbolicamente il rifiuto prodotto da due uccelli molto simili, se non fosse per il colore e per alcuni tratti comportamentali: il colombo e il piccione. Il primo incarna l’idea di amore e pace, il secondo è invece associato al degrado e alle malattie. Monumento e distruzione convivono in un medesimo simbolo. Ho lavorato il guano con la resina, ottenendo una materia che, alla vista, ricorda la pietra. La forma deriva da frammenti barocchi di un edificio sacro che per anni è stato invaso da questi volatili. Esteticamente l’oggetto risulta affascinante, suggestione accentuata dai cuscini di velluto che accolgono i frammenti. Ma questo fascino si incrina non appena, leggendo le specifiche, si scopre che il materiale è guano. A quel punto sorgono domande inevitabili: giudichiamo la superficie o la sostanza? Un oggetto simbolico deve attrarci per la sua patina (spesso tanto più credibile quanto più antica), oppure siamo chiamati a interrogarci sul suo contenuto, in maniera soggettiva e critica? Il simbolo, o il monumento, è davvero un dogma, o può – e deve – essere messo in discussione?
Se riguardi l’opera che hai donato all’Archivio Discontinuo oggi che cosa pensi e quanto, se, è cambiato il tuo lavoro?
Ho una memoria molto nitida di questo lavoro e mi sembra coerente e centrato anche oggi, in linea con un metodo personale di osservazione critica tuttora valido. Il mio approccio è fortemente ragionato ma al tempo stesso aperto agli imprevisti e alle dinamiche inafferrabili del quotidiano. Se parliamo di metodo di osservazione è cambiato poco, se parliamo di soggetto/oggetto in questo momento la mia attenzione è spostata su altre questioni.

La mostra “La stanza di Alessio” è visibile dal 1 al 26 ottobre
in Vicolo I Placido Mandanici n°2
a Barcellona Pozzo di Gotto, Messina.




