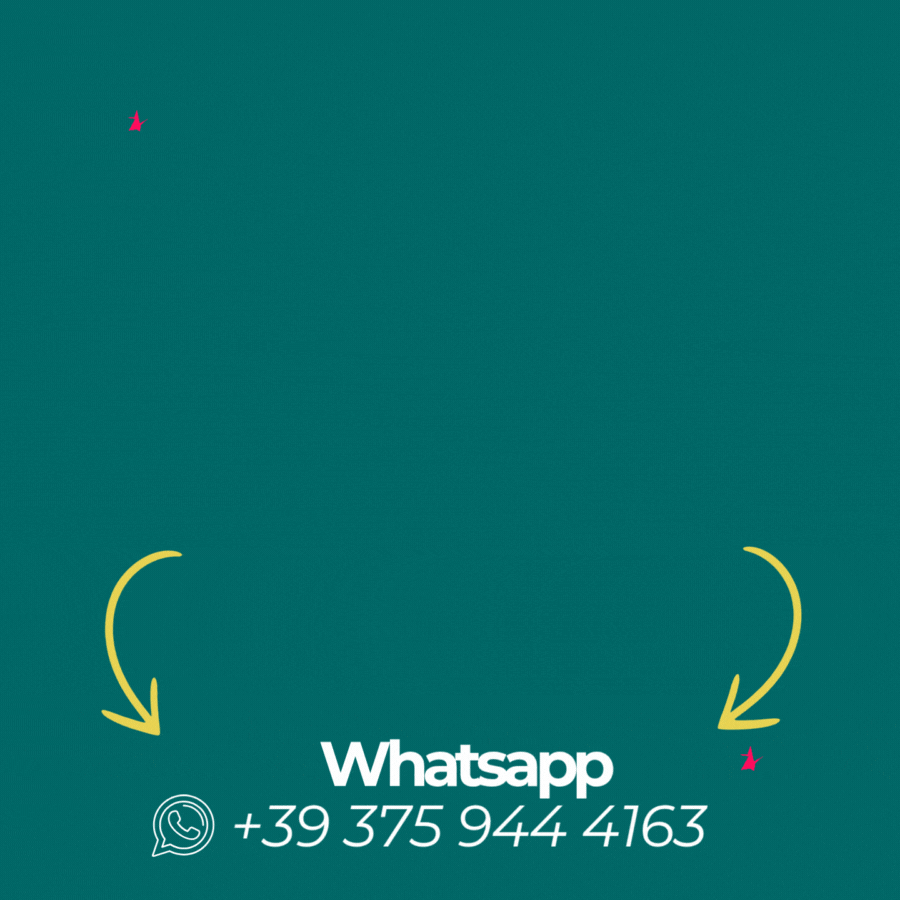Il nome di Emilio Isgrò risuona come un paradosso nel panorama dell’arte e della letteratura italiana.
Poliedrico per vocazione —giornalista, poeta, drammaturgo e infine artista concettuale— egli ha scelto la cancellatura non come atto di negazione, ma come la sua più potente affermazione creativa.
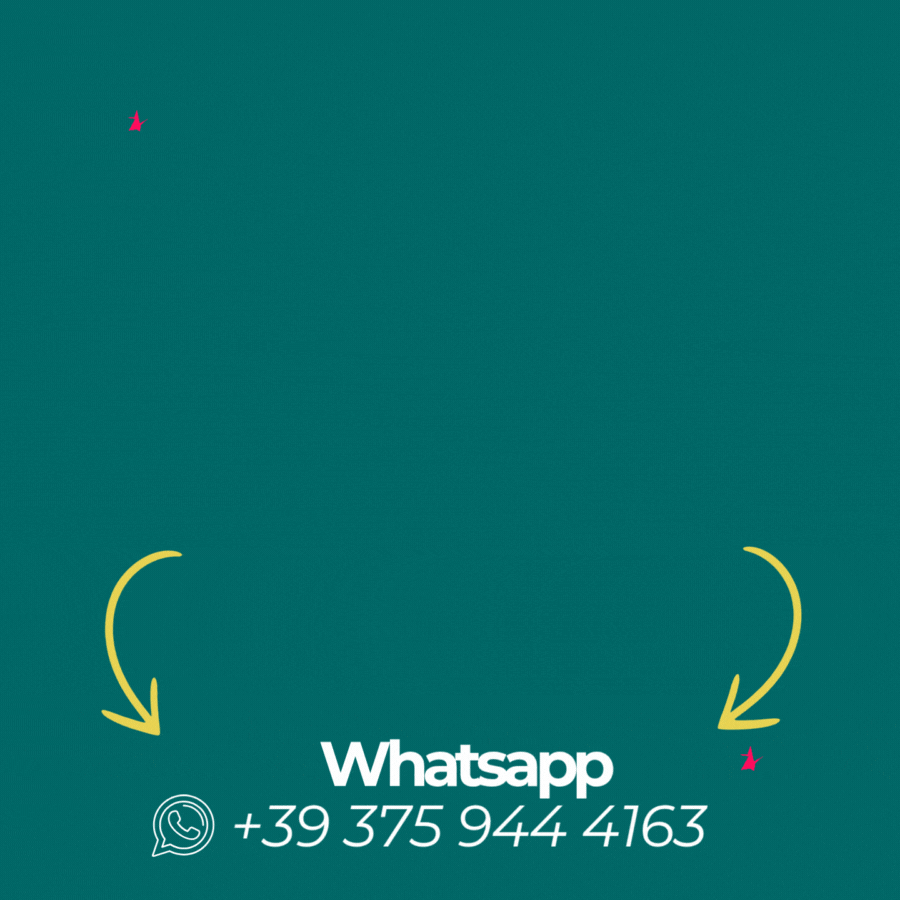
 Il suo recente libro, “Io non cancello – La mia vita fraintesa” (edito Solferino), è un viaggio autobiografico che svela il significato profondo di un gesto artistico spesso mal interpretato.
Il suo recente libro, “Io non cancello – La mia vita fraintesa” (edito Solferino), è un viaggio autobiografico che svela il significato profondo di un gesto artistico spesso mal interpretato.
L’intera carriera di Isgrò è segnata da un unico, potente tema: la Parola. Prima di diventare il celebre “cancellatore”, ha mosso i suoi passi nel giornalismo, nella poesia e nella scrittura teatrale. Questa intensa familiarità con il linguaggio ha portato alla rivoluzione che lo ha consacrato: la cancellatura.
Il concetto è sorprendentemente semplice, ma dirompente:
il Geesto. Consiste nell’intervento sull’oggetto testuale (libro, enciclopedia, mappa) annerendo o schiarendo gran parte delle parole.
L’Obiettivo. L’azione non è distruttiva. Cancellando, Isgrò non fa altro che dare più forza al testo, isolando poche parole residue che, estratte dal contesto, acquistano un significato nuovo e amplificato, stimolando una riflessione radicale sul linguaggio e sulla comunicazione.
L’artista, che ricorda l’attesa e la fatica prima che il suo lavoro venisse pienamente compreso, testimonia di quanto sia stato spesso frainteso: un pioniere concettuale la cui opera più celebre, una cancellatura su un libro, ha visto la luce nel 1964.
Nel libro viene trattato oltre l’arte visiva, l’impegno di Isgrò per la parola che si manifesta in modo monumentale nel teatro. L’Orestea di Gibellina non è una singola opera, ma un’opera teatrale articolata in diverse edizioni. Si tratta della riscrittura della trilogia di Eschilo, divisa in tre parti e ambientata nel luogo simbolo del sisma: Gibellina, rasa al suolo dal terremoto del Belice nel 1968.
Ciò che rende l’opera unica è l’originale impasto linguistico utilizzato: una commistione sapiente di italiano, dialetto siciliano e altri idiomi, che dona al dramma classico una risonanza contemporanea e profondamente radicata.
Portando l’epopea del giudizio e della rinascita sulle macerie, Isgrò ha dimostrato come la Parola, anche quando messa in discussione o frammentata, resti la base fondamentale per la ricostruzione, sia essa urbana, culturale o spirituale.
L’autobiografia di Isgrò è un atto di coraggio e lucidità, in cui l’artista rivendica il suo metodo: un’estetica della sottrazione che, al contrario della censura che mira a nascondere, cerca di svelare e illuminare.
In un’epoca di sovraccarico informativo, l’arte di Emilio Isgrò ci invita a riscoprire il peso specifico e la libertà delle parole che restano, trasformando la cancellatura in un gesto di speranza e in un potente strumento di analisi critica.
Per apprezzare al meglio, vi invito ad acquistare il libro e leggerlo.
(Loredana Aimi)