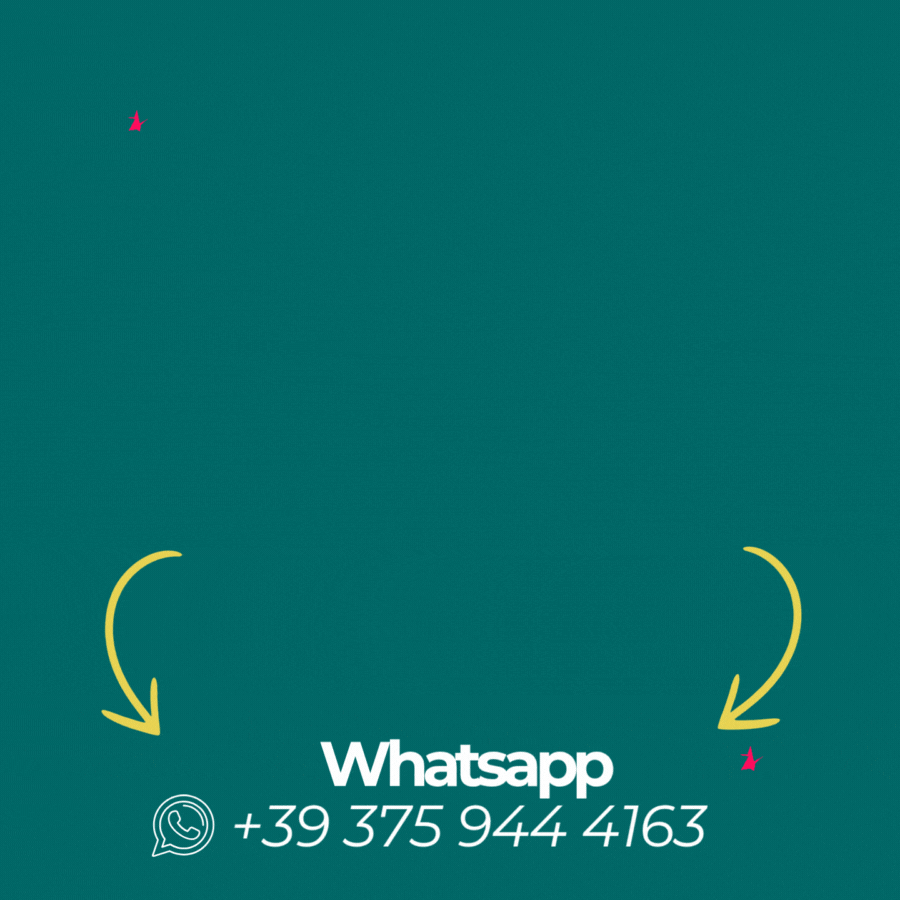Immaginiamo una bambina senegalese che arriva in Italia a due o tre anni. Non porta nulla con sé, tranne la sola ricchezza che un bambino possiede: lo sguardo spalancato sul mondo con alle spalle una storia di vulnerabilità e un futuro ancora tutto da costruire. Un esserino salvato dall’irrilevanza, dall’abbandono, dalla marginalità che inghiotte i più fragili senza far rumore. Una coppia italiana di coniugi senza figli la accoglie: benestante, colta, stabile, capace di offrire ciò che le norme, la psicologia dello sviluppo e la semplice umanità indicano come imprescindibile. La bambina cresce bene in una casa piena di luce, amore, cure costanti, abbracci spontanei, una rete affettiva ampia e accogliente. Anni di crescita serena seguono: la piccola si inserisce nella scuola con successo, sviluppa un forte radicamento sociale, stabilisce legami affettivi profondi, chiama “mamma” e “papà” gli adulti che l’accudiscono, gioca con i cuginetti, va a spasso con i nonni che stravedono per lei, cura dopo cura, febbre dopo febbre, sera dopo sera. Parla italiano con naturalezza, eleganza e proprietà di linguaggio, gioca, ride, impara che nel mondo esiste un posto sicuro che può chiamare “casa”, appare più grande della sua età per i ragionamenti maturi che è in grado di fare. È, in termini scientifici, la condizione ideale descritta da John Bowlby quando parla della “base sicura” necessaria per la crescita equilibrata del bambino [1].
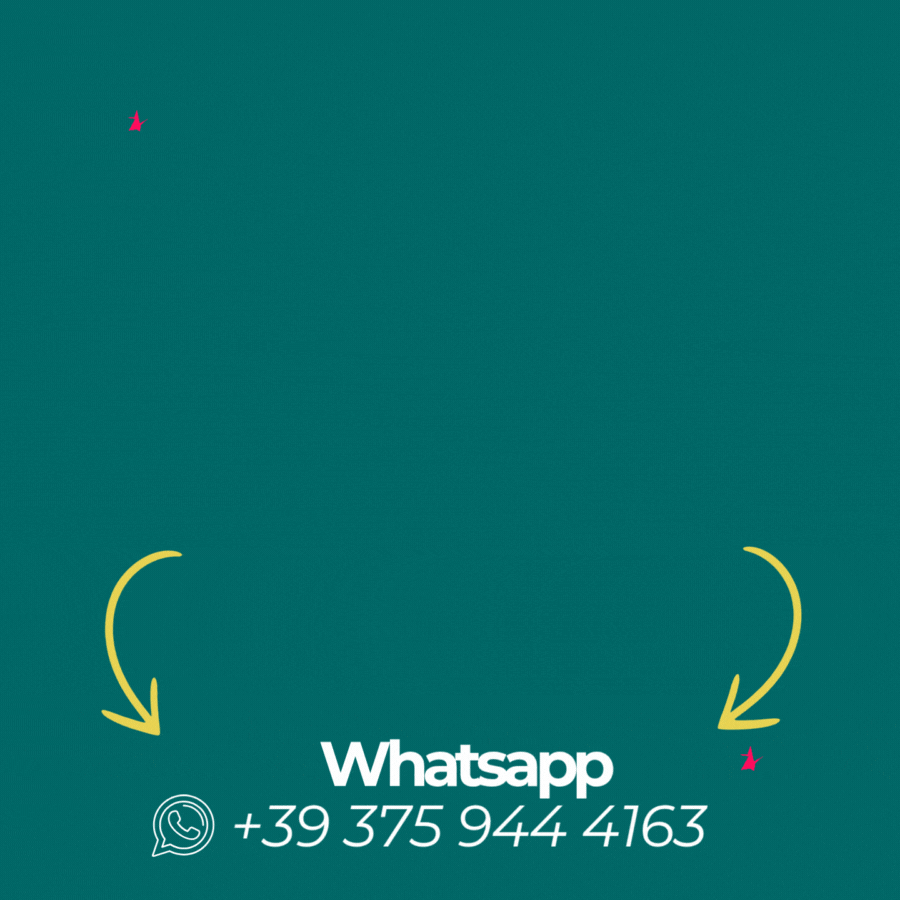
Poi accade l’inaccettabile.
Una cooperativa sociale – una di quelle che percepiscono rette pubbliche giornaliere per ogni persona ospitata – interviene con i servizi sociali per imporre un “ricongiungimento” con la madre biologica: donna senegalese che non parla italiano, priva di mezzi, priva di rete sociale, al margine di un contesto culturale che non è il suo, ignara perfino del contenuto degli atti che la riguardano, si “ricorda” di avere una figlia. Madre e figlia dovranno essere collocate insieme nella struttura della cooperativa: due rette, due presenze, due voci di bilancio. Due vite messe in un contenitore. Per recidere ogni legame con la famiglia affidataria, la bambina dovrà essere sradicata dal suo mondo: allontanata dalla casa che rappresenta il suo unico vero rifugio, dovrà cambiare scuola, compagni, abitudini, quotidianità, linguaggio emotivo. Non perché ciò risponda al suo interesse, ma perché una prassi burocratica – che ha ormai preso il posto del buon senso – lo impone: il ricongiungimento – parola nobile – diventa nella prassi una sottrazione.
Una sottrazione improvvisa, violenta, asimmetrica.
La bambina piange, si oppone, non vuole andare via da casa sua nè cambiare scuola. I genitori affidatari, non trovando sponda nel Tribunale dei minori, offrono il massimo: acquistare una casa per la bambina al fine di farla vivere con la madre naturale accanto alla loro, accompagnarla nel percorso, favorire un avvicinamento rispettoso, evitare un trauma inutile. È la soluzione più moderna, più umana, più conforme alla psicologia dell’attaccamento (Bowlby), alla teoria della mentalizzazione (Fonagy), alla continuità relazionale (Mary Main), alle linee guida europee sulla tutela dei minori (Council of Europe, 2011): ma questa soluzione viene anch’essa rifiutata dal Tribunale dei minori, supportato dai servizi sociali che meglio vedono la sistemazione della minore con la madre naturale in una stanza della casa famiglia gestita dalla cooperativa.
L’imperativo è uno: recidere i legami. Reciderli tutti. Bruscamente. Il prezzo? Una bambina sradicata da tutto ciò che la teneva in piedi e la rendeva felice. Il trauma non è un rischio: è un fatto. Come sottolineava John Bowlby, “la perdita improvvisa di una figura di attaccamento è uno degli eventi più traumatici che un bambino possa sperimentare”. Donald Winnicott, che lo definirebbe come una rottura della continuità dell’essere, qualcosa che scalfisce la struttura stessa del Sé, gli fa eco: “È la continuità che forma la personalità del bambino; la discontinuità imposta produce fratture interiori” [2]. Fonagy spiega che la perdita improvvisa di figure di riferimento produce disorganizzazione dell’attaccamento, compromettendo la capacità futura di costruire legami sani [3].
Da decenni sappiamo tutto questo. Eppure continuiamo a ignorarlo e in Italia, continua a prevalere una logica burocratica che considera il bambino un fascicolo da ricollocare, non una persona da proteggere. Sul piano giuridico, la scena è ancora più paradossale. La Corte di Cassazione ha stabilito che i legami affettivi costruiti nel tempo rappresentano parte dell’identità personale del minore e devono essere preservati (Cass. 14553/2021) [4]. In un’altra sentenza fondamentale (Cass. 18327/2019) la Suprema Corte ha cassato un provvedimento che aveva sradicato due fratellini dalla famiglia affidataria, affermando che «lo sradicamento affettivo è gravemente pregiudizievole» [5]. In Europa, la Corte EDU – nella celebre sentenza Strand Lobben c. Norvegia – ha affermato che «la vita familiare di fatto è tutelata quanto quella biologica», sancendo che i legami emotivi, quando stabili e significativi, godono della stessa protezione dei legami genetici [6]. La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, all’art. 12, impone poi di ascoltare la volontà del minore attraverso professionisti competenti [7]. Ma nel nostro Paese, troppo spesso, i minori vengono ascoltati solo quando i loro desideri combaciano con i decreti già scritti.
La domanda allora sorge spontanea: perché il diritto, la psicologia dell’età evolutiva, la giurisprudenza sovranazionale e la scienza dei legami affettivi vengono ignorati proprio da chi dovrebbe tutelarli? La risposta, purtroppo, sarebbe semplice e una domanda sorge spontanea: forse perché esistono interessi che nulla hanno a che vedere con i bambini? Il sistema delle cooperative sociali – che ospita minori e adulti vulnerabili – vive di rette. Non è un segreto: oscillano fra 70 e 120 euro al giorno per ospite, a seconda delle regioni e dei contratti. Quando madre e figlia entrano insieme in struttura, la rendita raddoppia. È il “paradosso dell’accoglienza” di cui parlano sociologi come Chiara Saraceno e Mauro Magatti: un sistema nato per proteggere, che finisce per generare incentivi economici opposti alla tutela effettiva del minore [8]. Non tutte le cooperative sono così. Ma il conflitto di interessi è strutturale. Ed è un dato che nessuno vuole affrontare. Gli scandali degli ultimi vent’anni dovrebbero aver insegnato qualcosa: dal Forteto con condanne definitive per maltrattamenti e abusi – al caso delle comunità umbre del “Piccolo Carro”, fino alla Val d’Enza, dove affidi, consulenze e ricostruzioni dei racconti dei minori venivano intrecciati dentro logiche di potere e denaro. Non è “fare di tutta l’erba un fascio”. È analizzare una realtà: quando i controlli mancano, la vulnerabilità diventa moneta.
In tutto questo, la madre senegalese non è un antagonista. È un’altra vittima. Non conosce la lingua, non conosce il contesto, non comprende le dinamiche che la sovrastano. Firma ciò che non capisce. Accetta ciò che le viene detto. È parte di un meccanismo più grande di lei, nel quale la sua povertà linguistica e materiale diventa strumento di decisioni prese altrove, da altri. E allora il punto non è – e non sarà mai – “madre naturale contro famiglia affidataria”. Il punto è: quale delle due soluzioni tutela l’interesse della bambina? La famiglia affidataria che per anni ha garantito amore, stabilità, integrazione sociale, identità, continuità scolastica? O – nell’immediato presente – una madre che non condivide la lingua, la cultura, il contesto educativo della bambina e che può esercitare il suo ruolo solo all’interno di una struttura che decide per entrambe?
In Italia resiste un fondamentalismo minorile: la sacralità della madre biologica È un dogma che sopravvive nonostante quarant’anni di studi che dicono l’esatto contrario: ciò che conta per un bambino non è il DNA, ma la presenza. Non il sangue, ma la cura. Non l’origine, ma la continuità. La Corte Costituzionale (sent. 183/1983) ha chiarito che la genitorialità è “funzione da esercitare, non diritto da rivendicare” [9]; Stefano Rodotà ricordava che “la persona è relazione e il diritto deve tutelare la continuità delle relazioni” [10]; Luigi Fadiga ammoniva che “il minore non è un oggetto da trasferire secondo disponibilità amministrative” [11]. La giurista Paola Ronfani (Università di Milano Bicocca) ripete da vent’anni che “Il diritto del minore alla continuità affettiva è superiore al diritto dell’adulto a riappropriarsi del ruolo genitoriale.” Eppure, nei tribunali minorili italiani, la biologia continua a essere trattata come un vaccino universale: nella vicenda qui evocata come paradigma, a prevalere non è la tutela della bambina, ma l’ideologia della biologia e la logica del sistema. Il risultato è lacerante: una piccola vita sarà spostata come un fascicolo, senza considerare il suo radicamento, i suoi affetti, la sua voce, la sua nuova identità. Si ripete spesso che “l’interesse del minore è la bussola”. Non è vero: l’interesse del minore è la frase più abusata d’Italia. Una formula che diventa pura retorica quando non coincide con ciò che psicologia, giurisprudenza e buon senso gridano con forza.
La verità, brutale e semplice, è che questa bambina non andava spostata. Non andava sradicata. Non andava ferita. La sua collocazione migliore – per legge, per scienza, per umanità – era la famiglia affidataria che per anni ha esercitato, in concreto, la genitorialità. Il resto è un cedimento culturale, istituzionale e morale che un Paese civile non dovrebbe più tollerare. Perché le ferite dell’infanzia non sanguinano fuori, sanguinano dentro. Come scriveva il grande psicoanalista René Spitz, “non guariscono mai completamente e lasciano ombre lunghe sull’intera vita”. Nel caso di una bambina africana di sei-sette anni, perfettamente integrata, felice, con legami profondissimi nella famiglia affidataria, la domanda è: perché forzarla a vivere in una struttura con una madre che, pur legittimata dall’affetto naturale, non possiede gli strumenti linguistici, culturali, economici ed educativi necessari per garantire stabilità? Perché ignorare la proposta degli affidatari – una casa accanto alla loro per permettere un ricongiungimento dolce e graduale – in favore di un taglio netto che contraddice tutto ciò che psicologi, giuristi e sociologi insegnano da decenni? Il sociologo Zygmunt Bauman parlava di “vite liquide” per descrivere la precarietà dei legami nella società contemporanea. Ma qui la fragilità non appartiene alla società: è imposta dal sistema. La bambina non vive una vita liquida per vocazione: la subisce per decreto. Il grande giurista Luigi Fadiga, già Garante per l’Infanzia, ripeteva che “il minore non è bagaglio da spostare, ma essere umano titolare di relazioni che non possono essere recise senza grave pregiudizio”. E l’avvocato matrimonialista Marina Toschi, studiando gli effetti degli allontanamenti improvvisi, osserva che “nel 70% dei casi si registrano regressioni, disturbi del sonno, perdita di fiducia negli adulti e difficoltà scolastiche”.
Alla luce di tutto ciò, la scelta corretta – giuridicamente, psicologicamente, umanamente – sarebbe evidente: privilegiare la famiglia affidataria che ha costruito legami, stabilità e integrazione, e accompagnare la madre naturale in un percorso rispettoso, graduale, linguistico e culturale, senza sradicare la bambina dal suo mondo. Invece, nel nostro Paese resiste una sorta di “fondamentalismo della genitorialità biologica”, una fede cieca nella supremazia della madre naturale anche quando tutto indica che, in quel momento, non è la soluzione migliore per il minore. Il risultato è che una bambina già vulnerabile diventa terreno di scontro tra apparati: la cooperativa, i servizi sociali, il giudice, la burocrazia. E la sua voce – che la Convenzione ONU obbliga ad ascoltare persino a tre anni – viene ignorata.
È legittimo allora chiedersi: in questo sistema, chi protegge i bambini dai loro “protettori”? Chi garantisce che l’interesse del minore non venga sacrificato all’ideologia o, peggio, alle logiche economiche dell’accoglienza? La risposta, oggi, è semplice e inquietante: troppo spesso nessuno. E finché continueremo a voltare lo sguardo altrove, a parlare di “procedure standard”, a recidere legami come si tagliano i fili di un fascicolo, continueremo a produrre bambini che imparano troppo presto la parola che più temono: abbandono. Perché chi ha imparato a chiamare “mamma” una donna che ti accarezza ogni sera, non può sentirsi dire, per decreto, che quella mamma non è mai esistita.
Bibliografia essenziale
J. Bowlby, Attachment and Loss, London, 1969.
D. Winnicott, The Child, the Family, and the Outside World, Penguin, 1964.
P. Fonagy et al., Affect Regulation, Mentalization, and the Development of the Self, 2002.
Cass. Civ., Sez. I, sent. 14553/2021.
Cass. Civ., Sez. I, sent. 18327/2019.
CEDU, Strand Lobben and Others v. Norway, Grand Chamber, 2019.
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, New York, 1989.
C. Saraceno, M. Magatti, Le politiche sociali in Italia, varie edizioni. Corte Costituzionale, sent. 183/1983.
S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, 2012.
L. Fadiga, interventi e relazioni come Garante nazionale per l’Infanzia.