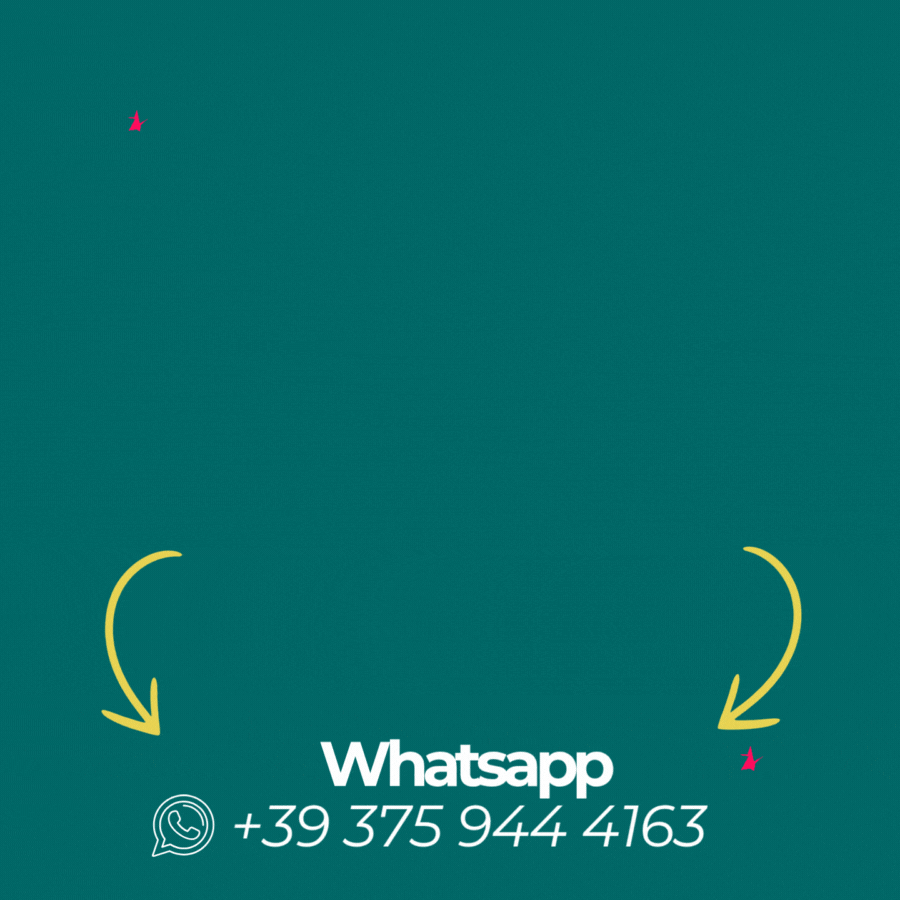L’idea di separare le carriere dei giudici e dei pubblici ministeri non è affatto nuova. Già all’Assemblea Costituente, giuristi come Piero Calamandrei e Giuseppe Dossetti sostennero che l’unità della magistratura fosse la miglior garanzia contro le ingerenze del potere politico¹. Prevalse allora la scelta di mantenere giudici e pubblici ministeri nello stesso ordine, sotto l’egida di un unico Consiglio Superiore della Magistratura, per evitare che l’accusa diventasse strumento dell’esecutivo. Fu una decisione saggia nel 1947, ma pensata per un’Italia uscita da una dittatura, non per un Paese che, settant’anni dopo, teme di ritrovarsi ostaggio di un potere giudiziario spesso inefficiente e autoreferenziale.
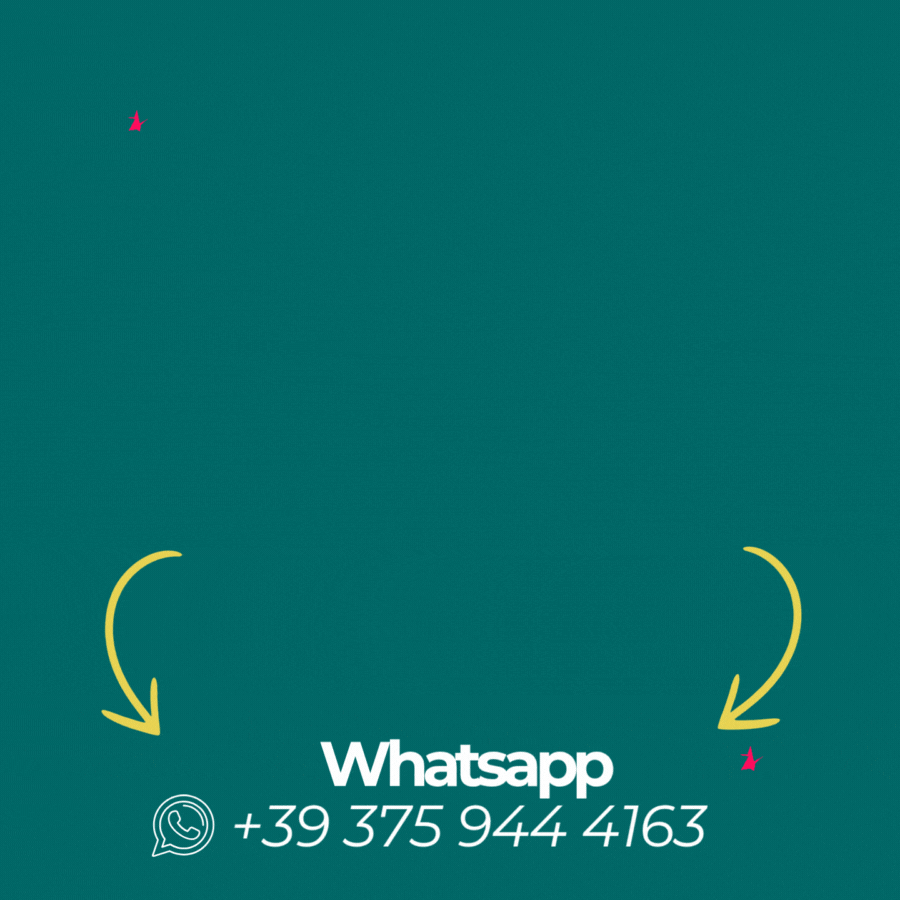
Da allora la proposta è tornata ciclicamente, quasi sempre come reazione alle guerre intestine tra magistratura e politica. Negli anni Novanta — dopo la fine della cosiddetta Prima Repubblica — la separazione delle carriere divenne un leit motiv di vari partiti e da allora, sotto l’egida dei vari Governi che si sono succeduti, i codici hanno subito varie modifiche, ma uno dei nodi più importanti rimane ancora lì: come garantire che chi accusa non sia parte di quel corpo giudicante che esamina il proprio operato?
Nel 2024 il ministro Carlo Nordio ha riaperto il cantiere della giustizia con la Legge 9 agosto 2024 n. 114³, intervenendo sul codice penale, di procedura penale e sull’ordinamento giudiziario non sempre in maniera appropriata e chiara; ha abolito il reato di abuso d’ufficio, limitato le intercettazioni, irrigidito le misure cautelari e ridotto la discrezionalità del pubblico ministero. Una riforma di dubbia efficienza, ma anche di potere: ha scardinato un equilibrio già fragile, preparando il terreno alla revisione costituzionale sulla separazione delle carriere, oggi contenuta nel Disegno di legge costituzionale n. 1353, approvato in prima deliberazione dal Senato il 22 luglio 2025⁴.
Il testo prevede che la magistratura «sia composta dai magistrati della carriera giudicante e da quelli della carriera requirente» e istituisce due distinti CSM e un’Alta Corte disciplinare⁵. Apparentemente, una modernizzazione: due binari per evitare conflitti di ruolo e garantire la terzietà del giudice. In realtà, il modo in cui la riforma è scritta apre scenari tutt’altro che rassicuranti. Non chiarisce chi governerà la carriera requirente, né definisce il rapporto tra il futuro CSM del pubblico ministero e il Ministro della Giustizia. Non dice, soprattutto, se l’azione penale resterà obbligatoria o potrà essere orientata da “priorità” politiche. E nel linguaggio del diritto costituzionale i silenzi valgono più delle parole⁶.
Nessuno, oggi, sostiene apertamente che il PM debba obbedire al Governo; ma la riforma cancella il vincolo strutturale che finora lo teneva al riparo da ogni influenza: l’appartenenza all’unico ordine giudiziario. Quando si separano le carriere senza scrivere chi garantisce la nuova indipendenza, si lascia un varco enorme per futuri interventi di legge ordinaria. Oggi la Costituzione dice che il pubblico ministero “gode delle stesse garanzie del giudice”; domani potrebbe bastare un regolamento ministeriale per stabilire “criteri generali di priorità” e, in nome dell’efficienza, decidere quali reati perseguire e quali no⁷. A quel punto l’azione penale obbligatoria – pilastro dell’articolo 112 Cost. – diverrebbe un concetto romantico, come la cavalleria donchisciottesca o la burocrazia onesta ed efficiente.
La riforma, insomma, nasce da un’esigenza reale – la necessità di distinguere nettamente chi accusa da chi giudica – ma rischia di tradursi in un’operazione di governabilità politica della giustizia. Lo riconoscono persino costituzionalisti favorevoli, come Sabino Cassese, che pur appoggiando la separazione ammonisce: «una cosa è l’autonomia, altra è la dipendenza organizzativa: se questa cade in mani politiche, l’indipendenza diventa teorica»⁸.
Sul fronte opposto, gli strenui difensori dello status quo gridano all’attentato alla Costituzione. L’Associazione Nazionale Magistrati parla di “fine dello Stato di diritto” – dichiarazione singolare, se pronunciata da chi per decenni ha gestito concorsi, nomine e poteri disciplinari in logiche di corrente e si scandalizzano se qualcuno osa toccare la loro autoreferenzialità⁹.
Non ci si illuda: la magistratura italiana, specie dopo Mani Pulite, ha assunto un ruolo in ordine al quale le correnti, nate per “pluralismo culturale”, sono diventate strumenti di carriera e di influenza. Se davvero l’unità della magistratura doveva garantire indipendenza, ha prodotto invece un feudo chiuso, capace di processare i politici ma non sé stesso.
Perché un’altra domanda sicuramente da porsi è questa: sino a che punto, sulla base di sacrosanti principi, si può difendere ad ogni costo una macchina giudiziaria che ha mostrato e continua a mostrare tutta una serie di limiti? E che magari ci dice che l’ufficio del PM va’ in qualche modo riformato? Condivisibile in tal senso, e da ritenere ancora valido, l’inascoltato grido di allarme lanciato dal primo presidente della Cassazione, Pietro Curzio nel 2022, durante l’inaugurazione dell’ anno giudiziario (2).
Anche se i dati che sciorina son di qualche anno fa, constatare che quasi i due terzi dei fascicoli usciti dalle procure non va a giudizio fa pensare al “molto rumore per poco”, e non dico per nulla perché è ben comprensibile che in alcuni casi le indagini vadano avviate.
Del restante 35% le condanne per i reati «minori» (ma molto diffusi) sono meno del 37%, per gli altri ancor meno. E parliamo solo del primo grado. Quantità che poi si affievolisce nei successivi gradi del giudizio. Però nel frattempo esci sui giornali (ma se poi vieni assolto quasi manco ti calcolano), paghi gli avvocati, le spese di giustizia etc. Quanti cittadini hanno in questi ultimi decenni pagato il prezzo di codesto malfunzionamento della macchina giudiziaria?
Ed è immaginabile cosa voterà al referendum tanta di questa gente che, come da statistiche, è proprio tanta tanta.
Solo nel 2021 vennero poi archiviati quasi mezzo milione di fascicoli.
Eravamo ai prodromi della riforma Cartabia che, come sappiamo, ha mostrato anch’essa i suoi limiti.
Anche per questo la separazione delle carriere è oggi necessaria: non per punire i magistrati, ma per restituire al giudice e al pubblico ministero la loro identità originaria e garantire una migliore efficienza degli Uffici di Procura.
Tuttavia, necessità non significa cecità. Servono tre modifiche decisive perché la riforma non degeneri nel controllo politico dell’accusa. Primo: inserire nel testo costituzionale che il pubblico ministero “fa parte del potere giudiziario e risponde solo alla legge”. Secondo: vietare in modo espresso ogni direttiva o priorità di politica criminale proveniente dal Ministero della Giustizia o dal Parlamento. Terzo: ridurre drasticamente la componente parlamentare nel futuro CSM requirente, limitandola al massimo a un terzo dei membri, scelti con maggioranze qualificate e non a colpi di maggioranza. In assenza di questi correttivi, il rischio è di passare da una magistratura corporativa a una magistratura controllata: non un passo avanti, ma un salto nel vuoto.
Il ministro Nordio, con la sua calma anglosassone, definisce la riforma “una riforma di civiltà”. E ha ragione: separare chi accusa da chi giudica è segno di maturità democratica. Ma la civiltà giuridica non si misura dal numero di toghe, bensì dalla loro libertà. Una giustizia “civile” senza indipendenza non è civiltà, è amministrazione del consenso.
Il vero scandalo, però, è un altro: che ancora oggi la giustizia italiana sia campo di battaglia tra poteri, anziché strumento di equilibrio. Dopo trent’anni di riforme mancate, la politica sogna di “normalizzare” la magistratura e la magistratura si muove per affrancarsi da tale tentativo di “normalizzazione”. Nel frattempo, i cittadini attendono processi rapidi, pene certe e sentenze giuste e continuano ad attendere.
La separazione delle carriere, se fatta bene, può essere un atto di liberazione: del giudice dall’ombra dell’accusa e del pubblico ministero dalla tentazione della politica. Se fatta male, diventerà solo un cambio di padrone. Perché una giustizia che serve la politica è un potere, ma una giustizia che serve soltanto la verità – quella sì – è una democrazia.
(di Letterio Grasso e Vicky Amendolia – Azione)
Bibliografia:
¹ Assemblea Costituente, Atti dei lavori preparatori della Costituzione, sedute 1946-47; Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Laterza
2. Il sole 24ore, 9 febbraio 2022.
³ Legge 9 agosto 2024 n. 114 (“Riforma Nordio”), Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2024.
⁴ Disegno di legge costituzionale n. 1353, Senato della Repubblica, 22 luglio 2025, Atti Parlamentari.
⁵ RaiNews, “Magistratura: ok del Senato alla separazione delle carriere”, 22 luglio 2025.
⁶ Questione Giustizia, “La riforma costituzionale della magistratura: le incognite e i naturali corollari”, 2025.
⁷ G. Flick, “La separazione delle carriere e la tutela dell’azione penale obbligatoria”, in Giurisprudenza Penale Online, 2025.
⁸ S. Cassese, “La giustizia tra indipendenza e responsabilità”, Corriere della Sera, giugno 2025.
⁹ Associazione Nazionale Magistrati, Opuscolo Separazione Carriere e nuovo CSM, Roma, 2025.