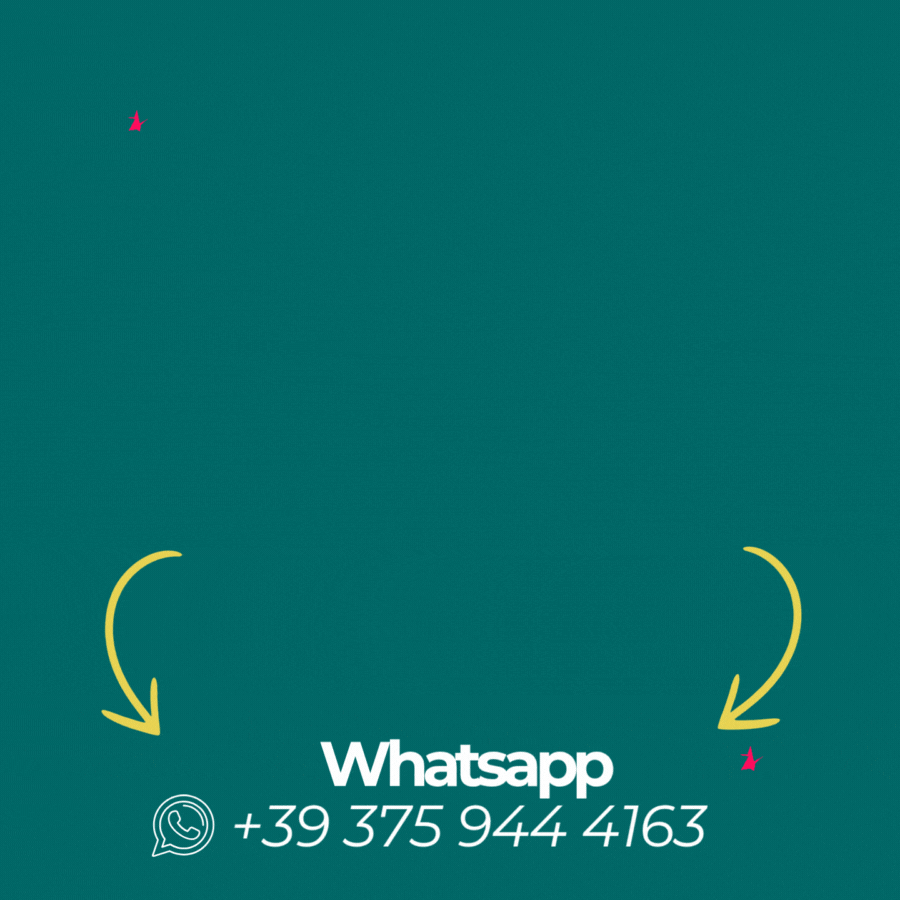Vivo in provincia di Messina da ormai 20 anni e, a meno della cadenza dialettale e l’innamoramento per il pesce stocco, ho preso molte abitudini locali come la colazione con brioche e granita o i rustici a cena e conosciuto unicità di limitata diffusione che stentano ad uscire oltre provincia.
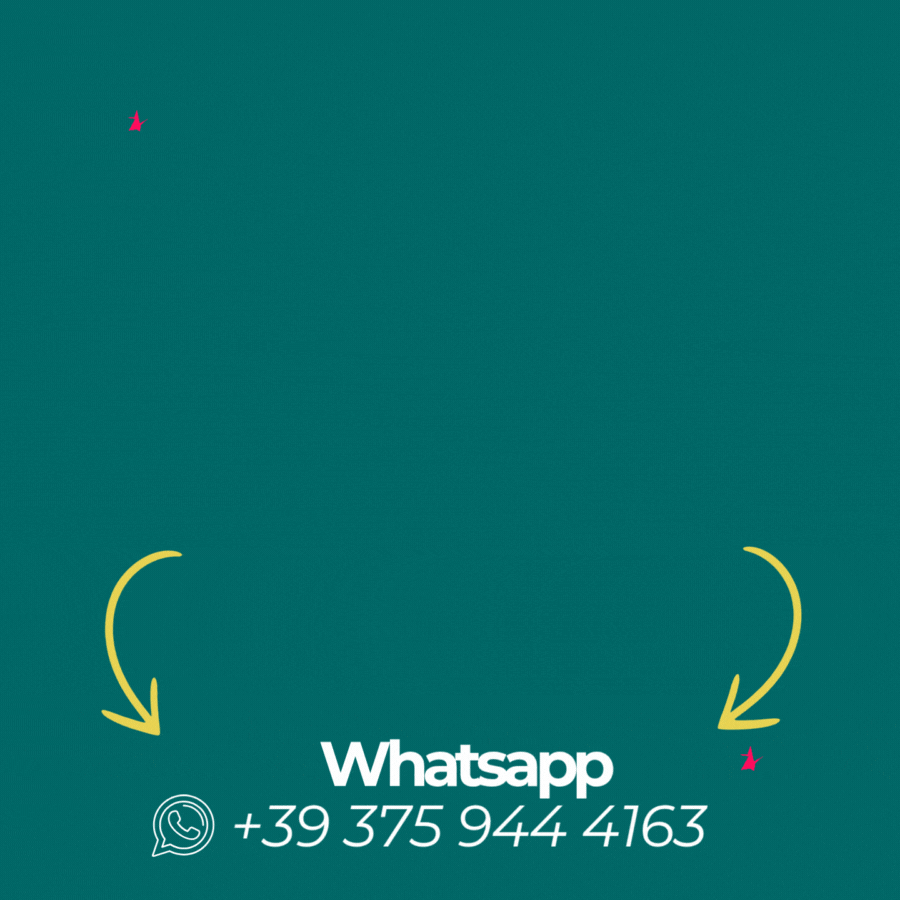
Una di queste è certamente il maiorchino, un’eccellenza gastronomica tutta siciliana, un formaggio antico e di non facile reperibilità nemmeno nei luoghi d’origine.
È tanta l’importanza di questo formaggio da diventare presidio Slow Food mentre il gioco della “maiorchina” (ruzzola col disco di formaggio) è bene immateriale UNESCO.
Parlare di maiorchino significa fare un passo indietro fino al 1600, periodo nel quale si fa iniziare la sua storia. Partendo dal nome, ci sono più origini probabili: alcuni lo fanno derivare dalla varietà di grano Maiorca che matura in corrispondenza del periodo di produzione del formaggio, altri lo correlano ad un formaggio ispanico, delle baleari o di Maiorca, altri ancora al mese di maggio, ma potrebbe essere ricondotto anche all’introduzione del minaccino nelle fasi di lavorazione.
I luoghi di produzione sono quella porzione dei monti peloritani che si estende da Novara di Sicilia e Montalbano Elicona fino a Santa Lucia del Mela.
Cosa caratterizza il maiorchino? Come descriverlo a chi non lo ha mai assaggiato? Riporto un estratto della scheda del formaggio consultabile sul sito ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio):
“Formaggio grasso, di lunga stagionatura, a pasta cotta e dura, di latte ovino intero e crudo prodotto da pecore di razze varie, stanziate nei territori alle pendici del versante nord dei Monti Peloritani in provincia di Messina, con un possibile apporto di latte di capra”, e poi lavorato “con le regole dettate dalla tradizione, nel periodo da febbraio a giugno; la stagionatura ideale è di circa 8 mesi, ma può anche essere più lunga e avviene in ambienti interrati, in pietra, dove la temperatura è costante per tutti i periodi dell’anno; il formaggio viene unto con olio di oliva”.
Già questa descrizione rende l’idea di un formaggio di ristretta produzione, legato ad una dimensione piuttosto familiare.
Il maiorchino si presenta in forme cilindriche a facce piane o comunque lievemente concave e di scalzo, ovvero di altezza della forma, compreso tra 10 cm e 12 cm. Caratteristico il diametro delle forme di 35 cm e peso tipico tra 10-12 kg fino ai 18 kg.
La stagionatura è variabile, dagli 8 ai 24 mesi, e legata alle cure del casaro, capace di gestire il tenore d’acqua praticando opportune forature alla forma. È un formaggio a pasta gialla con crosta sottile e dura di colore variabile fino al marrone per le stagionature più lunghe. La crosta è untuosa per via della cappatura della forma con olio di oliva operata in fase di stagionatura.
Il sapore, intenso, erbaceo, varia anch’esso con la stagionatura fino a prendere delle note piccanti.
Particolarmente apprezzato è il maiorchino di Novara di Sicilia che riporta circa il 35 % di latte caprino e si fregia del marchio PAT (prodotto agroalimentare tradizionale).
Il periodo di produzione si estende da febbraio fino a metà giugno.
Al latte crudo, munto da animali liberi al pascolo, si aggiunge caglio di capretto o agnello e la cagliata viene successivamente lavorata nelle fascere di legno dove comincia la fase della bucatura per l’eliminazione del siero e la pressatura della pasta.
A questa segue poi la salatura a secco e la stagionatura, su assi di legno, in locali freschi e asciutti.
La lunga lavorazione e stagionatura unita alle piccole produzioni comporta costi di produzione elevati e questa è la principale motivazione della bassa reperibilità odierna di tale eccellenza gastronomica. Il presidio Slow Food, in questo senso, intende spingere i casari a puntare sulla unicità di questa produzione e sulla necessità del mantenimento della tradizione e del know-how che potrebbe impattare positivamente sull’economia di tale comprensorio siciliano e sul suo ripopolamento.
Un grande aiuto a tutto questo potrebbe arrivare dall’istituzione di un consorzio di produttori prima, e di un disciplinare di produzione e relativo marchio DOP poi.
Iter che, se concluso, sarebbe il giusto “cacio sui maccheroni”.Sua Eccellenza… il maiorchino!
Vivo in provincia di Messina da ormai 20 anni e, a meno della cadenza dialettale e l’innamoramento per il pesce stocco, ho preso molte abitudini locali come la colazione con brioche e granita o i rustici a cena e conosciuto unicità di limitata diffusione che stentano ad uscire oltre provincia.
Una di queste è certamente il maiorchino, un’eccellenza gastronomica tutta siciliana, un formaggio antico e di non facile reperibilità nemmeno nei luoghi d’origine.
È tanta l’importanza di questo formaggio da diventare presidio Slow Food mentre il gioco della “maiorchina” (ruzzola col disco di formaggio) è bene immateriale UNESCO.
Parlare di maiorchino significa fare un passo indietro fino al 1600, periodo nel quale si fa iniziare la sua storia. Partendo dal nome, ci sono più origini probabili: alcuni lo fanno derivare dalla varietà di grano Maiorca che matura in corrispondenza del periodo di produzione del formaggio, altri lo correlano ad un formaggio ispanico, delle baleari o di Maiorca, altri ancora al mese di maggio, ma potrebbe essere ricondotto anche all’introduzione del minaccino nelle fasi di lavorazione.
I luoghi di produzione sono quella porzione dei monti peloritani che si estende da Novara di Sicilia e Montalbano Elicona fino a Santa Lucia del Mela.
Cosa caratterizza il maiorchino? Come descriverlo a chi non lo ha mai assaggiato? Riporto un estratto della scheda del formaggio consultabile sul sito ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio):
“Formaggio grasso, di lunga stagionatura, a pasta cotta e dura, di latte ovino intero e crudo prodotto da pecore di razze varie, stanziate nei territori alle pendici del versante nord dei Monti Peloritani in provincia di Messina, con un possibile apporto di latte di capra”, e poi lavorato “con le regole dettate dalla tradizione, nel periodo da febbraio a giugno; la stagionatura ideale è di circa 8 mesi, ma può anche essere più lunga e avviene in ambienti interrati, in pietra, dove la temperatura è costante per tutti i periodi dell’anno; il formaggio viene unto con olio di oliva”.
Già questa descrizione rende l’idea di un formaggio di ristretta produzione, legato ad una dimensione piuttosto familiare.
Il maiorchino si presenta in forme cilindriche a facce piane o comunque lievemente concave e di scalzo, ovvero di altezza della forma, compreso tra 10 cm e 12 cm. Caratteristico il diametro delle forme di 35 cm e peso tipico tra 10-12 kg fino ai 18 kg.
La stagionatura è variabile, dagli 8 ai 24 mesi, e legata alle cure del casaro, capace di gestire il tenore d’acqua praticando opportune forature alla forma. È un formaggio a pasta gialla con crosta sottile e dura di colore variabile fino al marrone per le stagionature più lunghe. La crosta è untuosa per via della cappatura della forma con olio di oliva operata in fase di stagionatura.
Il sapore, intenso, erbaceo, varia anch’esso con la stagionatura fino a prendere delle note piccanti.
Particolarmente apprezzato è il maiorchino di Novara di Sicilia che riporta circa il 35 % di latte caprino e si fregia del marchio PAT (prodotto agroalimentare tradizionale).
Il periodo di produzione si estende da febbraio fino a metà giugno.
Al latte crudo, munto da animali liberi al pascolo, si aggiunge caglio di capretto o agnello e la cagliata viene successivamente lavorata nelle fascere di legno dove comincia la fase della bucatura per l’eliminazione del siero e la pressatura della pasta.
A questa segue poi la salatura a secco e la stagionatura, su assi di legno, in locali freschi e asciutti.
La lunga lavorazione e stagionatura unita alle piccole produzioni comporta costi di produzione elevati e questa è la principale motivazione della bassa reperibilità odierna di tale eccellenza gastronomica. Il presidio Slow Food, in questo senso, intende spingere i casari a puntare sulla unicità di questa produzione e sulla necessità del mantenimento della tradizione e del know-how che potrebbe impattare positivamente sull’economia di tale comprensorio siciliano e sul suo ripopolamento.
Un grande aiuto a tutto questo potrebbe arrivare dall’istituzione di un consorzio di produttori prima, e di un disciplinare di produzione e relativo marchio DOP poi.
Iter che, se concluso, sarebbe il giusto “cacio sui maccheroni”.
(Giovanni Gargano)
Foto copertina: Salvatore Ferrara “U Murgaellu” ed il suo Maiorchino (Novara di Sicilia).